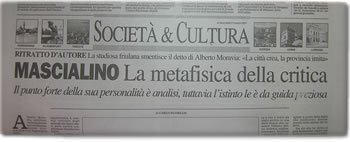Il film ‘3: 10 to Yuma’ in James Mangold (2007) e Delmer Daves (1957)
Category: Argomentazioni in Primo Piano,"Il film '3: 10 to Yuma' in James Mangold (2007) e Delmer Daves (1957)"
di Rita Mascialino
(parte di questo studio è apparsa anche in (CLSD) «Lunigiana Dantesca» N. 218, ottobre 2025, Rubrica di critica cinematografica 'La Settima Arte')
3:10 to Yuma (2007), Quel treno per Yuma, è un film per la regia di James Mangold (New York 1963), sceneggiatura di Halsted Welles, Michael Brandt, Derek Haas, interpreti principali il poliedrico Russell Crowe (Wellington 1964) come ottimo interprete del capo dei banditi Ben Wade; l’altrettanto ottimo Christian Bale (Haverfordwest 1974) nel ruolo del contadino Dan Evans, l’eccellente caratterista Ben Foster (Boston 1980) nel ruolo di Charlie Prince braccio destro di Ben Wade, tale che può essere ritenuto il terzo protagonista; colonna sonora di Marco Edward Beltrami.
Il film è un libero remake a colori del film in bianco e nero 3:10 to Yuma (1957) per la regia di Delmer Daves (San Francisco 1904-La Jolla 1977), memorabili interpreti Glenn Ford (Canada 1916-Beverly Hills 2006) per Ben Wade e Van Heflin (Walter 1908-Los Angeles 1971) per Dan Evans, sceneggiatura di Halsted Welles, canzone dei titoli di testa e di coda The 3:10 to Yuma (George Duning musica e Ned Washington testo) cantata da Frankie Laine (Chicago 1913-San Diego 2007). Il soggetto a monte dei due film fa riferimento a grandi linee e liberamente al racconto breve Three-Ten to Yuma di Elmore Leonard (New Orleans 1925-Detroit 2013) del 1953. Tra i doppiatori, tutti bravissimi, emerge in particolare il grande Roberto Gammino (Roma 1969) che per il difficile personaggio di Charlie Prince in Mangold è riuscito a contraffare con successo la melodiosità intrinseca alla lingua e alla voce italiana. La vicenda rappresentata non ha riscontro nel reale, bensì è opera di fantasia cui l’arte ha dato ingresso nella memoria letteraria e cinematografica.
Dapprima una parola sulle colonne sonore dei due film.
Frankie Laine ha reso immortale la canzone con la sua interpretazione vibrante di nostalgia di vita come dalla melodia musicale e dal testo poetico, nel quale domina il ricordo di ciò che è diventato leggenda, ossia ricordo di destini umani creati in seno all’arte e collegati al reale treno per Yuma trasfigurato nel simbolo universale del viaggio attraverso l’esistenza. I titoli di testa del film di Daves sono in sintonia con la canzone che funge da Leitmotiv musicale. Dal campo lunghissimo dell’inquadratura si vede una diligenza avvicinarsi lentamente nel piano medio e poi nel dettaglio in una terra vuota di ogni cosa concreta, di ogni meta nel reale. Il viaggio inquadra alla fine dapprima i magnifici cavalli neri al tiro della diligenza – il cavallo nero è, tra l’altro, per eccellenza simbolo della creatività artistica più profonda –, poi le sole ombre scure degli stessi comprese le redini sullo sfondo del nome a grandi caratteri bianchi del regista, come se alla guida di tali ombre ci fosse Delmer Daves stesso, infine inquadrando i magnifici cavalli neri che paiono viaggiare vigorosi nel più ampio spazio del cielo assieme alle loro ombre senza legami con il reale concreto, immagine che risulta così metafora dell’impalpabile mondo dell’arte cinematografica al servizio del regista, signore di tali ombre.
La malinconica e molto suggestiva colonna sonora di Marco Beltrami, in sintonia perfetta con il messaggio del film di Mangold, ispira il sentimento di una pacata rassegnazione all’ineluttabilità del reale al di là di ogni illusione di bei finali delle vicende umane, musica la quale ha il suo acme drammatico e intensamente emozionante nell’approssimarsi della morte ormai segnata del protagonista buono, Dan Evans, ed è seguita poco dopo la tragedia dal rinnovato ingresso della citata disillusa e triste rassegnazione che nell’inquadratura del treno che riprende il suo viaggio solitario seguito in corsa da un cavallo senza cavaliere fa passare in secondo piano la meta specifica del film per diventare motivo della più universale esistenza umana che termina nel nulla di ogni vicenda. Una nota ancora: sia nei titoli di testa in Daves, sia nell’immagine alla fine del film di Mangold che inquadra il treno si tratta di un viaggio, in Daves nell’immaginazione artistica, in Mangold nella rassegnazione dell’essere umano in generale in seno alle dure leggi dell’esistere.
Quanto ai film, si tratta di due opere che nel messaggio riflettono, come non può essere diversamente, le due visioni del mondo dei registi nel complesso intreccio di immagini e parole, di conscio e inconscio nella fantasia artistica inerente a esperienze esistenziali immaginate, psicologiche, socio-politiche, relative ai due generi maschili e femminili di cui è fatta la storia della vita, culturali nel senso più ampio del termine. Importante è quindi in questo studio, detto con un concetto di valenza generale, l’analisi dei temi sociali e psicologici nei due film, con maggiore dettaglio dell’opera di Mangold, meno lineare e più complessa della rappresentazione – bellissima – di Daves.
La comparazione semantica tra i due film, al centro di questo studio, mette particolarmente in luce nell’analisi e nella sintesi attuate le somiglianze e le differenze di superficie e profonde tra i messaggi, tralasciando di esporre quei dettagli, pure interessanti e valutati, tuttavia ritenuti ininfluenti a modificare il significato degli stessi, questo per non appesantire inutilmente la critica con un eccesso di particolari.
Per circostanziare l’analisi e avere la possibilità di uno sguardo generalmente panoramico degli eventi narrati, facciamo seguire cenni alle tre trame che trattano delle medesime vicende, diversamente elaborate in ciascuna di esse. Dapprima diamo spazio alla trama relativa al racconto di Leonard quale soggetto di riferimento originario dei due film, segue quindi la trama bruta del film di Mangold e successivamente, per le differenze principali negli eventi, del film di Daves – il termine ‘bruta’ m utuato dall’ambito della formula chimica cui, pur nel diverso codice, per così dire corrisponde.
In Elmore Leonard dunque il protagonista, Paul Scallen, è un deputy o vicesceriffo in Bisbee, e il capo della banda che ha assalito la diligenza da lui arrestato, Jim Kidd, è un giovane bandito, già processato, che non ha ucciso il vetturale della diligenza, ammazzato da un altro bandito secondo un testimone, e che deve pertanto scontare a Yuma solo cinque anni di carcere per rapina. Il vicesceriffo ha avuto l’incarico di scortarlo senza che nessuno lo accompagni in quella che è una cavalcata notturna verso Contention dove giungono nel primo mattino per attendere il treno per Yuma delle tre e dieci, città nella quale si trova appunto il carcere – Timpey, rappresentante della Ferrovia, ha procurato l’albergo e la stanza. Mentre i due attendono in albergo, c’è l’episodio agìto dal fratello del vetturale ucciso, che costringe Timpey sotto la minaccia del revolver a farsi aprire da Scallen con la scusa di portargli una tazza di caffè. Una volta dentro, Moons dichiara di voler uccidere Kidd che crede l’assassino di suo fratello, ma viene presto disarmato con audacia da Scallen e la cosa termina lì. Non vi sono, contrariamente a quanto sta nei film, soste al bar del paese, né cene a casa dell’incaricato Scallen, né presenze femminili di sorta – la moglie di questo solo viene evocata assieme ai tre figli nella mente del marito che scaccia presto tali pensieri per non venire distratto e indebolito dall’emergere degli affetti. In albergo a Contention, nell’attesa, Scallen e Kidd si conoscono meglio dialogando assieme. Charlie Prince, braccio destro di Jim Kidd, non ha il soprannome Princess, Principessa, che c’è per altro solo in Mangold. Tuttavia quando Jim dalla stanza d’albergo chiede a Scallen che cosa debba rispondere a Prince che lo sta chiamando dalla strada, Scallen gli dice di rispondergli – come verrà riportato in entrambi i film con qualche variante – che gli scriverà ogni giorno da Yuma, ciò che allude, per quanto indirettamente, all’amicizia da parte di Prince per il capo considerata piuttosto stretta, al che segue la risata di Kidd che ha recepito l’allusione di Scallen. Proseguendo molto in breve, giunge la scena finale piuttosto concitata. Quando vicesceriffo e bandito sono ormai giunti nei pressi del treno, Jim Kidd, ormai in rapporto di stima e quasi amichevole con Scallen, dice a Charlie Prince di aspettare un minuto ponendo anche le mani avanti per fermarlo come se dovesse parlare con Scallen, ma Prince improvvisamente gli grida di abbassarsi, al che Kidd esita ad abbassarsi perché non vorrebbe che Scallen venisse ucciso, esitazione che consente a questo di uccidere egli stesso Prince, ai cui piedi striscia Kidd per essere comunque vicino all’amico. Allora Scallen afferra violentemente per il collo Kidd e lo spinge sul treno assieme a sé. Tutto finisce bene nel racconto per i due protagonisti, scambiando essi anche qualche cenno di humor maschilmente cameratesco e qualche mezzo sorriso di stima reciproca altrettanto cameratescamente. Molti dettagli ulteriori ricompaiono nei due film, anche se diversamente distribuiti, dettagli comunque ininfluenti per il significato sia del racconto che dei due film.
Senza voler entrare nel significato dei nomi in Leonard – il nome Kidd, anche se con due d, non ha bisogno di alcun chiarimento –, segue un solo riferimento ritenuto importante. Il cognome Scallen è interpretato in questo studio non secondo i vari esiti etimologici su base scientifica di cui quello più probabile potrebbe essere quello collegato a to scale, scalare, montagne o livelli in altezza, così come Scallen da contadino e mandriano ha dato una mano allo sceriffo contro gli Apache e, avendo fatto un buon lavoro, è stato nominato vicesceriffo o deputy, salendo di grado con un tipo di stipendio, poi ha raggiunto uno stipendio più alto come quello attuale, con l’aggiunta di speciali emolumenti in caso di cattura di banditi e adesso spera di diventare sceriffo, salendo ancora di grado e con uno stipendio ancora più alto, ossia ha scalato vari livelli di lavoro e stipendio e ancora scala. Prendendo come punto di partenza il problema della trasformazione in Mangold del protagonista Evans, corrispondente a Scallen, in uno zoppo, visto che ciò non ha riscontro né in Leonard – dove vale l’etimologia a monte di Scallen citata più sopra e non valida nel contesto dei due film –, allora c’è una semplice assonanza, oltre alla somiglianza grafica, di Scallen con scalene, che rimanda nell’accento tonico sulla prima sillaba al termine inglese e inoltre quasi del tutto coincide con la pronuncia dello stesso. Il termine inglese deriva dal greco skalenos, disuguale come nel triangolo scaleno relativamente ai lati disuguali e per l’associazione metaforica al passo instabile nella diversità dei lati-arti significa anche zoppicante. Quest’assonanza del nome in Leonard pare essere stata colta da Mangold, il quale ha reso appunto zoppo il corrispondente personaggio Dan Evans.
Passiamo alla trama bruta del film di James Mangold, regista che sempre approfondisce i risvolti sociali e psicologici nei suoi film, oltre che avere la massima cura della perfezione tecnica delle inquadrature, dei colori, dell’audio, delle immagini, di ogni dettaglio.
Dan Evans, un contadino dell’Arizona, ha contratto forti debiti con un ricco proprietario terriero di Bisbee che richiede il rimborso dei prestiti, altrimenti sequestrerà la terra di Evans che così sarà totalmente rovinato, anche perché il creditore ha fatto deviare il ruscello da cui anche Evans traeva l’acqua necessaria all’allevamento del bestiame. Come avvertimento fa bruciare il fienile del contadino che, ormai disperato, si presta per duecento dollari, a tanto ammonta il suo debito, a scortare a Contention City il bandito Ben Wade, che ha appena assalito e rapinato la diligenza con la sua banda uccidendo il cocchiere e che è stato catturato nel bar di Bisbee con il contributo di Evans che lo distrae parlandogli. Quando stanno per partire per Contention, Dan ordina al figlio quattordicenne William, che sa sparare e vorrebbe accompagnarlo per essergli di aiuto, di stare a casa, ma il figlio di nascosto lo seguirà e gli darà poi una mano in molte circostanze, non lasciandolo solo mentre ormai sta morendo. Dopo varie avventure i due, contadino e bandito assieme ad altri uomini di scorta in aiuto e protezione, giungono a Contention dove Evans dovrà mettere sul treno per Yuma il bandito perché lì venga processato e impiccato per i suoi delitti, ultimo fra questi l’uccisione di quasi tutta la scorta, tranne tra l’altro un agente Pinkerton lasciato ancora vivo nella diligenza assalita e svaligiata dei denari trasportati così che riesce a minacciare un bandito di ucciderlo se non riconsegneranno i denari rubati, ma anche del bandito stesso per avere questo trasgredito i suoi ordini di non lasciare testimoni delle loro rapine, così che vengono uccisi entrambi. Evans e Wade, dopo varie avventure affrontate durante il viaggio a Contention con gli altri uomini della scorta, aspettano il treno nella stanza di un albergo, mentre gli altri accompagnatori, cui si aggiungono lo sceriffo del luogo e ulteriori suoi aiutanti, attendono l’arrivo della banda appostati nell’ingresso dell’albergo, mentre il figlio controlla l’arrivo della banda dall’esterno. Durante il tempo trascorso insieme i due protagonisti, il buono e il cattivo per così dire, hanno modo di conoscersi meglio, mentre intanto tutti coloro che dovevano far fronte assieme a Dan Evans alla banda che sarebbe intervenuta per salvare il capo si ritirano perché non vogliono rischiare la loro vita. Così alla fine è il bandito Ben Wade che, apprezzando il nuovo amico Dan Evans, decide di aiutarlo nella sua impresa senza che venga ucciso dalla banda. Tuttavia, quando Wade sta sul treno e i due uomini sono entrambi contenti della loro alleanza, il suo ordine di non sparare dato a Charlie Prince non viene eseguito da questo che è ormai vicino a Dan con l’arma in pugno a braccio teso e che lo uccide con un vero e proprio accanimento di colpi di revolver alla schiena e frontalmente. A questo punto Ben Wade, capo i cui ordini di cessare il fuoco sono stati disattesi, uccide il suo braccio destro e tutta la sua banda. Poi sale sul treno da solo essendo morto Dan Evans, consegna l’arma che gli era stata tolta al momento del suo arresto e poi recuperata e consegnatagli da Charlie Prince, quindi chiama con il fischio d’intesa il suo fedele cavallo che corre parallelamente al treno per Yuma e che è tutto ciò che gli resta, implicitamente come può essere, nell’eventualità di una evasione da Yuma, carcere da cui è già evaso un paio di volte in passato, come ha rivelato poco prima a Evans. Un finale dunque che termina nella tragedia con la morte del giusto, di Dan Evans. Questo in somma – o bruta – sintesi.
A conclusione dell’analisi di questo complesso film verrà dato spazio ad alcuni speciali dettagli semantici stanti precipuamente sul piano delle associazioni e delle attrazioni indirizzate dall’inconscio di cui l’approfondimento psicologico di James Mangold forma parte rilevante nel messaggio del film.
In Daves la trama è molto lineare e le differenze maggiori con Mangold stanno: nel fatto che Dan Evans non sia azzoppato; nella mancanza dell’incendio del fienile; nel fatto che il figlio di Dan non segua il padre per aiutarlo in quanto ancora fanciullo; nella mancanza delle avventure che affrontano bandito e scorta durante il viaggio a Contention; nella presenza di un personaggio, Alex Potter, che sarà l’unico a restare fedele al suo incarico di fare la guardia fuori dall’albergo fino all’ultimo prima di essere ucciso da Charlie Prince; nella rappresentazione del funerale del vetturale e nel tentativo fallito del di lui fratello ucciso che vorrebbe uccidere a sua volta Ben Wade entrando con l’inganno nella stanza dell’albergo dove sta con Evans; inoltre soprattutto nel lieto fine, con Evans che si salva dai banditi saltando sul treno secondo il consiglio di Wade e assieme a lui; nell’uccisione da parte di Dan, una volta sul treno, di Charlie Prince, mentre sta correndo ancora volendo liberare il suo capo cui è molto legato.

Immagine: ilcinefiloinsonne.wordpress.com/2015/07/03/quel-treno-per-yuma-1957
Dopo avere a grandissime linee circostanziato la trama del racconto e dei due film, inizia l’analisi per temi e personaggi che li rappresentano esplicitando così la qualità del tessuto sociale e umano relativo alle due epoche, partendo dalle donne che compaiono sia in Daves (1957) sia in Mangold (2007). Si tratta delle due madri di famiglia e mogli dei protagonisti e di due prostitute che hanno dovuto smettere di cantare nei saloon per aver contratto la tubercolosi e che ora sono cameriere nel bar di Bisbee che si trova in una zona dal clima secco più favorevole a una eventuale guarigione.
In Daves dunque viene presentata, nell’ambito di un’ottica ancora piuttosto tradizionale – sebbene non completamente –, una figura di madre e di moglie quale essere sacrificale, ossia che, ad esempio, non pone la propria bellezza in primis, di fatto si presenta con abiti da lavoro, comunque semplici, come pure non ha come meta una realizzazione di sé visibile nella società, ossia una possibile ricerca di soddisfazione per propri talenti da scoprire e da esprimere avendo il riconoscimento della comunità. È una donna, di cui la brava attrice Leora Dana interpreta l’anima profonda propria di un femminile volto al consolidamento degli affetti per il bene della famiglia, anche a formare di conseguenza la base più stabile della società in positivo. Come accennato, il suo aspetto non mette in risalto la sua bellezza che pure c’è, i capelli sono pettinati in un’acconciatura semplice, ordinata ma non particolarmente attraente, comunque una donna che non pone tutto sull’apparenza, sull’apparire. Alice lavora duramente nei campi, nella casa, per aiutare il marito, per sostenere la famiglia, è donna dai sentimenti nobili. Quando il marito, pur avendo assistito all’assalto alla diligenza da parte della banda di Ben Wade e all’uccisione del conducente Bill Moons e di un bandito, non è intervenuto in nessun modo contro i delinquenti, essa avrebbe desiderato che avesse fatto qualcosa in difesa degli assaliti, non fosse stato solo a guardare e a subire la prepotenza dei delinquenti. Al che Dan risponde sentendosi umiliato e rimproverato piuttosto severamente dalla moglie, che non poteva farsi ammazzare lui stesso combattendo inutilmente contro tutta la banda dove avrebbe avuto la peggio. La donna, pur usando un tono meno severo, tuttavia insiste dicendo che i figli avevano dovuto vedere come il padre fosse rimasto inerte, ciò che non sarebbe stato un buon insegnamento da dare per il loro futuro di uomini, per il loro ingresso nella società la cui struttura e i cui giusti avrebbero dovuto difendere. Per tale tipo di donna è quindi importante l’educazione dei figli, maschi nella fattispecie, ossia è importante il modello paterno, non esattamente il modello macho, ma il modello dell’uomo onesto e nel contempo non vile, che agisce magari anche solo dialogando per aiutare chi si trovi in difficoltà, un modello positivo, responsabile socialmente, scevro comunque da qualsiasi sfoggio di violenza e prepotenza. Visto che il marito in qualità di maschio adulto e capo famiglia era l’unico che si poteva esporre nell’azione, sarebbe dovuto, secondo la moglie, comunque intervenire in qualche modo, pur rischiando di diventare vittima esso stesso magari addirittura assieme ai figli. Rilevante è dunque per questo tipo di donna che i figli debbano crescere con una personalità audace all’occorrenza contro i violenti, ossia debbano essere forti psicologicamente, capaci di intervenire a difesa di coloro che fossero deboli e indifesi, per cui essi dovevano poter contare su di un adeguato modello paterno, apprezzato per altro anche e soprattutto dalla madre, figura fondamentale nel messaggio del film. Tutto ciò ovviamente in seno ai valori in auge all’epoca sia della seconda metà dell’’Ottocento dove è ambientata la vicenda frutto di fantasia, sia per le proiezioni del diverso modo di vivere nella prima metà del Novecento cui fa capo il film. I ragazzi, per difendere il comportamento del padre di fronte ai rimproveri e alle pretese della madre – perché di questo si tratta –, dicono che se avessero fatto qualcosa in aiuto degli assaliti e dei morti, sarebbero stati uccisi tutti, ossia, pur dispiacendosi che il padre non sia intervenuto, sembra giustifichino il razionale comportamento paterno, specialmente difeso dal ragazzino più grande. In ogni caso il più piccolo, che già aveva chiesto al padre se non facesse niente di fronte all’assalto e all’ordine del bandito di dargli i loro cavalli perché non potessero andare dallo sceriffo, aveva gridato dietro al bandito che se ne stava andando lasciandoli così a piedi, che il padre lo avrebbe ucciso, il piccolo dunque non si rassegna a non fare proprio niente, dice qualcosa, ma si tratta appunto di un bambino, meno riflessivo del ragazzino più grande che dà in ogni caso ragione al padre, pur sentendosi a disagio per aver dovuto vedere come il padre non avesse fatto di meglio che obbedire al bandito. In questa evenienza donna e bambino, due soggetti che non possono agire in tali circostanze non avendone le forze necessarie, sono accomunati da un medesimo sentimento: avrebbero agito o voluto agire diversamente, sarebbero intervenuti in qualche modo – facendosi verosimilmente ammazzare dai delinquenti –, avrebbero voluto in ogni caso che intervenisse il capo famiglia. Ben Wade, che non ha seguito gli altri membri della sua banda andandosene con essi da Bisbee dopo l’assalto, perché è voluto stare più a lungo con la cameriera del bar, viene catturato e prima di partire per Contention viene ospitato a cena a casa di Evans per ingannare il suo uomo di fiducia, Charlie Prince, sul reale trasferimento di Wade a Contention, ossia facendogli credere con un programmato falso incidente alla carrozza nei pressi della casa di Evans, che il capo dei banditi sia quindi partito per Contention appena rimessa in piedi la stessa, mentre invece sarà ospitato dagli Evans e partirà dopo. A tavola i due bambini elogiano le abilità di tiratore scelto del padre perché non si arrendono ancora al fatto che il padre non abbia agito all’occorrenza, ma abbia tenuto un atteggiamento secondo loro di sottomissione. Entrambi i figli esaltano variamente il padre di fronte a Ben Wade, implicitamente anche per una certa ammirazione per l’audacia che il bandito come tale ha necessariamente. Questo atteggiamento di moglie e figli mostra come all’epoca i figli maschi e le donne si aspettassero azioni coraggiose e anche di estremo pericolo da padri e mariti, dagli uomini, ossia come la considerazione delle potenzialità maschili fosse molto alta e da essi tutti pertanto si aspettassero gesta audaci e coraggiose. Dan, all’inizio del film quando ritorna a casa dopo aver assistito all’assalto alla diligenza senza essere intervenuto, dichiara alla moglie, che pare, come più sopra, lo rimproveri per questo, per non essere stato in grado di agire come essa si sarebbe aspettata, di non fare niente per rimediare alla situazione di estrema indigenza in cui si trova la famiglia per via forte siccità, Dan risponde umiliato di non saper compiere azioni eroiche o impossibili per lui, dice anche di non poter far piovere. Si tratta di una figura d’uomo che parla di tempi che iniziano a essere diversi, in cui la Legge pare avere più valore della forza fisica e delle iniziative individuali dei maschi, azioni che paiono essere meno necessarie che in passato e meno auspicabili. In altri termini: nella presentazione di Dan Evans viene evidenziato un inizio di cambiamento del ruolo maschile nella società, che i bambini paiono non comprendere o apprezzare del tutto – la moglie stessa, ancora dopo che Dan si è offerto di scortare il bandito a Contention, incarico rischioso, dice con evidente eccitazione che figli sono fieri di un padre che scorta un temibile bandito e anche lei stessa lo è – ancora persiste nella donna e nei piccoli comunque il modello dell’uomo forte e impavido, sprezzante del pericolo –, al che l’uomo sorride senza convinzione. Anche in High Noon (1952), per fare una breve comparazione sul piano dei due generi, le donne, tranne la moglie quacchera dello sceriffo Will Kane che per motivi religiosi non vuole usare violenza in nessun modio e vorrebbe che lei e il marito fuggissero senza aspettare i tre banditi, le donne vorrebbero che i mariti aiutassero lo sceriffo perché gli devono essere grati dell’ottimo lavoro svolto a vantaggio della città, ossia non lo lasciassero solo ad affrontare i banditi venuti per ucciderlo, ma essi si tirano indietro tutti abbandonandolo al suo destino. In ogni caso, dopo la partenza di Dan, il figlio piccolo è tutto orgoglioso perché il padre tornerà con un mucchio di soldi, mentre quello più grandicello è consapevole del fatto che duecento dollari non valgano la vita del padre, se non dovesse tornare, ossia i vecchi valori del macho mostrano di cominciare a traballare anche in lui. Dan comunque, pur non sentendosi un macho, mostra di non essere un vile, essendo ormai determinato a rischiare per il denaro utile alla sopravvivenza familiare. Dà valore quindi al coraggio che serve inoltre per lasciare eventualmente una buona memoria di sé nella società, ai figli. Dan si è proposto per i citati motivi per l’incarico di scortare il bandito, ma non è entusiasta né eccitato per l’impresa, perché consapevole del rischio che corre, anche con la Legge a suo vantaggio. La donna resta a casa, non essendo in grado di partecipare a un’azione che richiede in ogni caso la diversa personalità e fisicità possedute dai maschi, audaci o meno audaci. Nel ’57 le donne ancora non erano – credibili o incredibili – poliziotte con pistola in mano e comandanti di gruppi di maschi come nei film attuali, per cui essa resta a casa, ma si preoccupa per il marito e per la famiglia, per cui ad un certo punto capisce di aver preteso troppo dal marito rimproverandolo e vuole fare ammenda, ossia fa qualcosa di audace essa stessa per quanto le è possibile: prende il calesse e va a Contention City, da sola, scambiando poche parole con alcune sue amiche durante una sosta lampo nel viaggio, amiche che non la accompagnano per sostenerla, ossia la lasciano andare da sola. Entra nell’albergo e vede il compaesano Alex Potter, il beone del paese che tutti conoscono come persona un po’ sempliciotta, ma buona e onesta, nonché generosa, appeso dai banditi al lampadario della hall. Inorridita e spaventata dalla brutale realtà che il marito si trova ad affrontare al di là dei sogni da maschio macho, sale le scale di corsa chiamandolo ad alta voce incurante di qualsiasi rischio.
Alex Potter è un bevitore noto come tale in paese come accennato e anche ciò rimanda a Mezzogiorno di fuoco, dove l’unico assieme a un ragazzino a rendersi disponibile ad aiutare lo sceriffo contro i banditi, quando tutti coloro cui chiede aiuto lo abbandonano, è proprio un alcolizzato dal grande cuore.
Riprendendo l’analisi: quando la moglie Alice parla con il marito a Contention, c’è il grande momento dei sentimenti che stanno al centro di questo film. Essa, che ritiene di aver contribuito a mettere in pericolo marito e famiglia con i suoi rimproveri e le sue pretese di audacia di cui sopra, gli dice di non essersi voluta lamentare quando sembrava che lo rimproverasse per non essere intervenuto per contrastare la prepotenza dei banditi e anche per non fare niente per uscire dalla situazione causata dalla siccità magari chiedendo denaro in prestito, come gli aveva consigliato. Appunto gli dice – bugia commovente – che lui ha capito male, perché lei è contenta di vivere come vive, nel sacrificio, ma insieme, negli affetti familiari e nel sostegno che questi danno alla coesione della famiglia che essa non vuole ledere in nessuna misura come si inferisce dal suo discorso finalizzato a far desistere il marito dall’azione rischiosa. Qui stanno a confronto due diverse modalità di intendere il sostegno dato alla famiglia, secondo le diverse personalità e potenzialità maschile e femminile. Specificando: Dan, a Contention, dopo la morte di Alex Potter, non rischia più per i soldi o per il rimprovero proferito dalla moglie, ma perché soprattutto ormai non può tirarsi indietro, come le rivela, dopo il sacrificio di Alex Potter, ucciso per il suo sostegno alla Legge, facendo il suo dovere per la legalità ed essendo un amico sincero, ossia dopo la sua morte non può lui essere così vile e ingrato da indietreggiare, ossia prosegue nella sua azione in primis per onorare il sacrificio di Potter. Anche qui un breve rimando, seppure in diversa elaborazione di dettaglio, a High Noon, quando lo sceriffo che sta fuggendo avendo pur a malincuore dato retta alla moglie, gira durante la fuga il calesse e torna indietro perché non se la sente di essere vile quando il dovere lo chiama. La donna di Dan dunque non vorrebbe più che il marito rischiasse la vita per nessun motivo, i sentimenti per i cari prevalgono o sono per la donna quanto di più importante vi sia, mentre nell’uomo, secondo il messaggio del film, i valori sono un po’ diversi – come in High Noon – , nel senso che ancora più della propria vita e addirittura degli affetti familiari valgono il senso del dovere, un senso dell’amicizia, della gratitudine, della salvaguardia delle regole su cui si sostiene la società, ossia vi è il richiamo più profondo dell’imperativo kantiano, superiore a ogni compromesso utilitaristico, dunque un senso di responsabilità e di onore posti in un orizzonte diverso da quello proprio della donna e che va, ribadendo, persino oltre gli affetti più forti. Si tratta nel film di Daves di due qualità della moralità, maschile e femminile, presentate entrambe come componenti indispensabili alla positiva esistenza della vita familiare e della società secondo i diversi apporti.
Dopo che Dan è rimasto solo a condurre il bandito sul treno per Yuma, c’è comunque la moglie che lo aspetta trepidante per la sua sorte, di nuovo, seppure in diversa elaborazione, come lo sceriffo Will Kane di Mezzogiorno di fuoco resta solo ad affrontare i tre banditi che sono arrivati a Hadleyville per vendicarsi di avere catturato e mandato in carcere il loro capo Frank Miller, e soltanto la moglie, dopo vari dissensi, tornerà da lui non appena, già nel treno per abbandonarlo visto che non ha voluto lasciare la città per sfuggire ai banditi (Lunigiana Dantesca, La Settima Arte, N. 160, 2020) udirà gli spari e, per vero amore e affetto, correrà in paese, ancora in abito da sposa, e gli sarà comunque vicino salvandogli la vita due volte di seguito. Anche in questo film di Zinnemann sono evidenziate le diverse potenzialità del maschio e della femmina: quando la donna uccide uno dei banditi sparandogli alla schiena il quale stava a sua volta per uccidere con sicuro successo il marito, si sente quasi male dopo aver sparato al bandito alla schiena per l’azione che non avrebbe mai voluto compiere, in seguito, presa come ostaggio da Miller, ultimo dei tre banditi restato in vita, la donna rischia la propria vita facendo quello che può, ossia sorprendendo e distraendo il bandito, così che il suo uomo può con freddezza sparare a Miller uccidendolo e salvando così la moglie e se stesso. Ci sono altre derivazioni, di minuto dettaglio, da High Noon in Daves come anche in Mangold seppure ancora più diversamente elaborate.
Profondamente emozionante è la scena in cui la donna in piedi sul calesse, alla fine del film, quando il treno è partito, guarda in distanza per vedere se il marito sia ancora vivo e lo vede assieme al bandito che lo ha aiutato a salvarsi e a salire con lui nel treno per Yuma – come Ben Wade le aveva quasi promesso che avrebbe cercato di renderle Dan sano e salvo. Entrambi i maschi sorridono lieti quasi la figura di questa donna li ripaghi del rischio, come abbia compiuto il miracolo che le spetta di compiere per tradizione, ossia di fungere con il suo amore e il suo spirito di sacrificio a sostenere come quarta colonna il marito e la famiglia e anche addirittura quasi a portare sulla retta via il bandito. A conferma: Ben Wade, il predone che uccide come regola di vita, dice a Dan Evans in albergo, che gli piacerebbe un giorno avere una moglie come la sua e figli con cui cavalcare educandoli, ossia non cita Velvet la donna del locale dell’Eldorado per la quale ha speso tanto denaro in una sola sera o Emmy del bar di Bisbee per quanto dolcissima, donna anche quest’ultima da cui sa che non tornerà, implicitamente, perché incapace essa comunque malgrado la dolcezza del suo carattere di operare il miracolo. Anche il bandito vorrebbe dunque un giorno una vita onesta, tutto ciò dovuto alla figura femminile della madre e della moglie presentata da Daves, vorrebbe pertanto far parte della società non violenta perché ha conosciuto una donna come Alice, lui che è abituato a donne che non gli hanno mai fatto venire in mente la bellezza dell’onestà e degli affetti veri, dell’avere una famiglia quale cellula valida per la società – dice alla cameriera che non tornerà da lei perché non si ferma mai in un posto oltre l’indispensabile, ossia non pianta radici da nessuna parte. Certo, Alice è una donna che rinuncia alla sua realizzazione per così dire pubblica nella società, ma non rinuncia alla sua realizzazione di educatrice nell’ambito familiare, della quale essa riconosce il fattore imprescindibile per la solidità nel positivo anche nell’ambito sociale. Al proposito, ricapitolando, la vediamo in due momenti diversi entrambi relativi alla sua funzione di educatrice e di sostegno della vita. Appunto all’inizio rimprovera il marito di essere stato solo a guardare l’assalto alla diligenza e di avere poi obbedito agli ordini dei banditi restando senza agire e così dando un tale esempio negativo ai figli, gli uomini del domani, e gli rimprovera anche di non fare niente per uscire dalla precaria situazione economica dovuta alla siccità così che l’uomo si umilia chiedendo un prestito al più ricco del paese il quale gli rifiuta ogni aiuto in modo ipocritamente gentile, ma quando essa va a Contention in cerca del marito che sta rischiando la vita, fa marcia indietro, ossia ritira il proprio rimprovero iniziale e anche la sua gioia quando ha visto che Dan compie l’azione rischiosa di cui i figli sono andati fieri e anch’essa, diventando in pieno la moglie e la madre che educa con fermezza sì, ma soprattutto con il suo affetto a sostegno della struttura familiare, della vita.
Ed è a questo tipo di donna cui nel finale viene dedicato dal regista Daves l’omaggio dell’inquadratura che la esalta come il cardine chiave della vicenda nella famiglia e nella società, un’inquadratura che è la sua celebrazione quale più grandiosa non potrebbe esserci, come se la vita girasse attorno a lei, suo massimo riferimento per tutti. Mentre in piedi nel calesse sorride radiosa dopo aver visto salvo il marito e guarda in alto come a ringraziare il cielo della incipiente pioggia che porrà fine alla siccità, le grosse gocce iniziali di acqua luminosa scendono su di essa avendo la più splendida spazialità di una pioggia di diamanti che cadano in festa a onorare la qualità di questa donna – la pioggia non ha la medesima spazialità delle gemme preziose relativamente al bandito, come a comparazione evidente è mostrato subito dopo dal tipo di pioggia visibile ad hoc dietro di lui, un maschio fuori legge, dove essa ha la spazialità della più violenta e fitta caduta di frecce, comunque ostile. Anche la componente sociale, nella figura di Butterfield, rappresentante della Ferrovia, condivide la pioggia preziosa, ma significativamente in second’ordine, in un flash, stando egli a terra, in basso rispetto alla donna, fuori dal calesse dove essa, appunto più in alto, domina nell’inquadratura ad essa dedicata, ciò che dà a questo tipo di madre e moglie il trionfo che secondo il regista le spetta. Anche Dan Evans sente nelle mani la pioggia che arriva come a benedizione della sua famiglia, della vita che riprende, gocce tuttavia che non si vedono propriamente nell’immagine, come se l’uomo ricevesse indirettamente nelle mani la loro diamantina preziosità che resta appannaggio della donna, quasi un suo dono.
Veniamo adesso alla donna di Mangold, la moglie di Dan, la quale viene considerata dalla critica in generale una donna importante nella vita della famiglia. In questa analisi essa risulta esserlo molto meno e non così positivamente in ogni caso – di fatto, tra l’altro, Dan Evans ha un rapporto importante con il figlio William e anche con Wade, anche con Butterfield, ma dopo aver lasciato la casa familiare la donna scompare da tutto il film e Dan non cita più la moglie e solo si adira con Wade quando questi dice, pungendolo sull’onore maschile, che doveva essere stata una bella donna prima di sposarlo, nonché la cita per dire a Butterfield, prima di dirigersi alla stazione, di consegnarle mille dollari – i figli non possono ancora ricevere denaro – implicitamente alla sua possibile morte, come egli sa che potrebbe verificarsi e veramente avverrà e questo è tutto quanto riguarda la moglie, poche, rivelatrici sequenze iniziali e un paio di velocissime citazioni. Wade stesso quando sono soli a cena ironizza ridacchiando sulla sua performance da gran dama per averla al contrario riconosciuta come donna di un locale malfamato di San Francisco. Nel film di Mangold, in questa analisi, essa risulta donna di non grandissimi valori, così secondo ciò che esprimono le immagini e le parole che essa pronuncia nella manciata complessiva delle poche inquadrature e battute che la riguardano per altro solo agli inizi, nel prosieguo del film essa, ribadendo, non appare più e perde con ciò qualsiasi importanza come è negli intendimenti del regista – come le due prostitute che spariscono dal film, anche da quello di Daves. Essa, dall’aspetto curato, non pare lavorare in modo particolarmente duro e pare essere sempre in attesa delle azioni del marito per criticarle, mentre sta solo a guardare senza mai intraprendere qualcosa di positivamente attivo per la famiglia oltre che cucinare, questo per quanto si evidenzia nel film. L’unica cosa che sa fare educativamente parlando, è curare, anche qui solo superficialmente, il cosiddetto bon ton sociale del figlio, riprendendolo quando esso, come si dice, risponde un po’ decisamente contrapponendosi al padre – nel testo originale inglese, anzi inglese americano, spesso il figlio adopera la parolaccia shit, anche in locuzioni per così dire fiorite, per riferirsi a ciò che non condivide. La donna solo richiama il figlio pronunciando il suo nome come a rimproverarlo senza per altro riuscire a cambiare alcunché nel merito, perché non rappresenta la figura della grande educatrice come nella migliore tradizione. Chi educa il figlio con l’esempio e le proprie parole, sarà il padre, non questo tipo di donna che, per quanto emerge nel film, rappresenta la propria insufficienza. Al contrario Dan dice a William che ha preso la parte migliore di sé e, al bandito, che il figlio non sarà mai un delinquente perché da lui ha preso la strada dell’onestà, non citando mai nell’educazione del figlio la moglie e madre di William in nessun modo né esplicito, ma neanche implicito, anzi escludendola da ogni campo educativo dove essa impersona un fattore di assenza. Ma vediamo più in dettaglio in che cosa consistono le significative differenze di personalità e di valori tra le corrispondenti donne dei due film nelle due diverse epoche in cui essi sono stati ideati, girati, pubblicati.
Quando, ai primissimi inizi della vicenda, il marito e il figlio quattordicenne sono in allarme nella notte per il rumore inquietante che sentono attorno alla loro casa e si alzano subito dal letto dove stavano, mentre essa non si alza immediatamente e neppure si gira tranne che con il volto verso gli uomini già in piedi, bensì restando girata dall’altra parte, non fa niente in aiuto, solo dice stando a letto che il rumore è forse dovuto al vento che soffia, ossia per così dire mette la testa nella sabbia esprimendo la sua opinione errata senza verificare alcunché. Durante l’incendio del fienile – che, come più sopra, non esiste in Daves e neanche in Leonard –, mentre il marito e il figlio William, interpretato da un veramente ottimo Logan Lerman (Beverly Hills 1992), rischiano la vita facendo uscire i cavalli e portando fuori le selle, così salvandoli dalle fiamme, la donna, non in abiti adatti a un intervento di emergenza, solo compare in camicia da notte – tenendosi a distanza di sicurezza dal fuoco – senza fare alcunché, senza aiutare né rischiare niente in qualche modo neppure per il figlio, solo chiamando una volta lamentevolmente il figlio che in ogni caso non le dà retta. Per altro il marito ha una gamba di legno, è non poco azzoppato per un incidente militare e comunque agisce poderosamente nel fare uscire i cavalli come già fa il figlio e, successivamente non solo richiamando questo, lo afferra e lo trascina via dall’incendio un secondo prima che il fienile infuocato gli rovini addosso. Ribadendo: sembrerebbe che chi stia a guardare senza fare mai niente sia appunto la moglie che non presta alcuna collaborazione di nessun tipo, lasciando tutta l’iniziativa e i rischi ai due maschi. Certo, può sembrare scontato come le donne non avessero e non abbiano le stesse capacità fisiche di un uomo, né la sua personalità, ma in questo così diverso atteggiamento verso il pericolo è visibile e percepibile nel messaggio del film una sottolineatura implicita relativamente ai diritti di uguaglianza con i maschi reclamati nell’attualità dalle donne, diritti che secondo le immagini non paiono del tutto a diritto reclamabili. Di fatto la moglie, dopo il disastro conseguente all’incendio, non ha altro da dire al mattino al marito, che le ha mentito dicendole di aver saldato il debito con l’uomo che gli aveva fatto il prestito e nel dire ciò sorride poco simpaticamente come schernendolo – il discorso della moglie non riguarda ciò che è successo nella notte, ma è incentrato su di sé. Alla risposta di Dan di aver saldato il debito, anche se solo in parte, questo per aver speso del denaro per le medicine per il figlio piccolo malato di tisi e per acquistare il fieno e l’acqua, la moglie continua imperterrita dicendo che avrebbero potuto decidere insieme il da farsi, nella fattispecie il pagamento parziale del debito, al che Dan risponde chiedendole se essa avesse mai potuto decidere diversamente. Mangold evidenzia ancora di più l’opinione che appare negativa su questo tipo di donna, attenta in primo luogo ai propri diritti anche nell’emergenza trascorsa. Dan Evans, quando la moglie dice che avrebbero potuto decidere insieme, replica che, anche insieme, non avrebbero comunque potuto far piovere per far cessare la siccità, ponendo con ciò il regista la questione dei diritti della donna in un ambito piuttosto relativo. Al proposito, il Dan Evans di Daves, come accennato più sopra, dice alla moglie sentendosi piccolo di fronte al suo rimprovero, che lui non può far piovere, ossia usa il singolare riferito a sé, come per rimarcare che la moglie nei suoi confronti pretenda cose che lui non può e non sa fare, risposta non coinvolgente la questione delle rivendicazioni femminili di propri diritti, ma solo alludente ai tempi che iniziano a cambiare nella nuova società postbellica, nel nuovo tipo di uomo che inizia ad annunciarsi non più del tutto macho. Proseguendo, nel remake di Mangold, Alice non ha l’iniziativa di prendere il calesse o un cavallo o farselo prestare nel caso per sostenere il suo uomo, ossia essa rimprovera al marito di non fare niente come fosse un buono a nulla e, si deve constatare secondo quanto sta nel contesto filmico, soprattutto critica con parole, toni di voce ed espressioni del volto qualsiasi cosa decida o faccia il marito. Ad esempio: lo umilia se non fa niente e lo critica se fa qualcosa come scortare il bandito a Contention per Yuma, ciò che per altro non fa amorevolmente, ma con una evidente sfumatura di non approvazione, persino di disprezzo, come Dan non capisse niente, ossia non sapesse quello che fa, come fosse uno sciocco che affronti situazioni di pericolo irresponsabilmente, senza esserne all’altezza, mentre Dan le dice realisticamente che, se non cogliesse l’opportunità per quanto rischiosa di scortare il più pericoloso dei banditi, dovrebbero abbandonare casa e terra in pochi giorni non potendo essi, anzi lui, fare altro. Le dice che lo fa anche per non essere guardato dai figli con poca stima, e non guardato da lei, anzi ad un certo punto, durante la questione dei diritti, Dan le dice espressamente di smettere di guardarlo così come sta facendo. Il regista quindi conferma anche esplicitamente come gli sguardi della donna siano di disprezzo per il suo uomo e come questo non le interessi più di tanto come tale, ossia come sia carente non solo l’amore, anche l’attrazione, ciò di cui è consapevole Dan, senza comunque sviluppare un’avversione per lei essendo un uomo comprensivo e paziente. In altri termini: la moglie è sempre o quasi in atteggiamento di diniego, scuote impercettibilmente la testa per mostrare il suo disaccordo e anche disprezzo nell’espressione, ribadendo ancora, per tutto ciò che dice e ha deciso di fare il marito.
Per chiarire, prima di continuare, onde cercare di evitare possibili equivoci, ciò che viene esposto in questa analisi riguarda le idee per come vengono rappresentate sul piano oggettivo in Daves e Mangold: si tratta di idee identificate e chiarite nella semantica del loro intreccio di immagini e parole, azioni.
Tornando alla donna, quando William, trascinato dal padre fuori dal fienile in fiamme, guarda la madre e ne intuisce le opinioni, raccoglie come da un suo tacito benestare il fucile dal suolo per uccidere chi lo abbia appiccato e se ne stia andando impunito a cavallo dopo aver promesso a Dan che, se non restituirà entro una settimana il denaro prestatogli dal suo capo, incendierà anche la casa. La madre non si oppone al fatto che stia per sparare a chi ha compiuto il danno e mostra con ciò di condividere le posizioni non solo di William, ma anche del figlio piccolo che vorrebbe che il padre sparasse a chi ha incendiato il fienile – entrambi i figli non hanno fiducia nella Giustizia, nello sceriffo e preferirebbero farsi giustizia da sé, appartenendo ancora alla modalità esistenziale che comincia a diventare trascorsa, a cambiare, come dimostra in pieno invece la personalità del padre. Nella circostanza, al contrario, interviene il padre stesso abbassandogli il fucile e dicendogli che ci avrebbe pensato lui dopo. A questo punto William gli risponde non dandogli fiducia e con una certa arroganza mista a dispiacere gli dice che sa che il padre non lo farà, non credendo che avrebbe il coraggio di sparare e uccidere il malfattore, ossia non condivide il suo carattere più propenso al dialogo – democratico – che all’uso della forza, della violenza, carattere che il figlio nella sua età giovanile interpreta come debolezza, come pure il figlio più piccolo, ma anche la moglie. Al proposito William all’inizio del film, ancora a letto con il fratellino malato e che respira con difficoltà, sta leggendo un libro che narra di un fuorilegge capace di uccidere, ciò che evidenzia come il ragazzo, al momento, abbia come modello non il carattere del padre, ma quello dei delinquenti – in seguito prevarrà il modello paterno, ma di questo più avanti. Mangold presenta dunque questa donna – che si tinge di modernità, soprattutto di attualità – non positivamente come comprova anche il prosieguo e il finale del film: essa, come accennato, scompare completamente dalla scena dopo aver fatto i suoi costanti quanto inefficaci cenni di diniego con il capo, di disprezzo e superiorità, e aver detto le mezze parole, ciò con cui vorrebbe essere interpellata dal marito sui soldi spesi e altro. Si tratta di una figura di donna che risente della posizione – di crisi – della donna nella società attuale, posizione che il messaggio del film non pare considerare come una possibilità di progresso da parte femminile, visto come presenta la figura della moglie, per la quale ha scelto un’attrice, la statunitense Gretchen Mol dal nome tedesco, bravissima nella parte non proprio simpatica affidatale. Come più sopra, pare che essa, durante la cena con il bandito e gli altri uomini della scorta, voglia nascondere di essere stata, molto veritieramente, donna di un certo locale a San Francisco, ma quando Ben Wade le parla degli occhi verdi e bellissimi, come i suoi, di una donna del locale, essa, che sa di essere stata quella donna, non resiste all’elogio dei suoi occhi e li mostra con una certa altezzosità del tutto fuori luogo, mentre il bandito in un’abile interpretazione di Russell Crowe la guarda ridacchiando ironicamente, ossia prendendo in giro le arie da gran donna che essa sfoggia sentendosi superiore, ma in realtà essendo come nel riconoscimento che appare sicuro da parte del bandito Ben Wade. Interessante è la comparazione con il discorso sugli occhi verdi di una donna che il bandito anche in Daves rivolge alla moglie di Dan a cena mentre rimangono soli a tavola, discorso che la donna pare seguire con piacevole interesse mostrando anch’essa i suoi occhi che potrebbero essere pure verdi. Il marito interrompe questo dialogo e si mostra contrario ai discorsi tra Ben e Alice sugli occhi e tutto il resto. Ora veramente non c’è nessun tutto il resto da nessuna parte nel breve dialogo tra i due. Volendo azzardare un’ipotesi andando molto per il sottile, a tutto il resto potrebbe alludere il marito relativamente a fatti a conoscenza sua e della moglie occorsi in un eventuale locale di San Francisco – città dove il padre della donna possedeva una nave –, locale dove Dan avrebbe potuto conoscere la futura moglie, collegamento che sembrerebbe in ogni caso molto sgradito al marito che liquida la faccenda appunto con tutto il resto. Ciò solo in un’ipotesi interpretativa che sebbene possibile nel contesto, tuttavia non è qui oggettivamente sostenuta in quanto basata solo su indizi di cui nessuno riesce ad avere valore oggettivo di verità. Ad ogni modo la differenza fondamentale tra le due mogli nel medesimo frangente, al di là dell’ipotesi abduttiva abbozzata rimanendo essa tuttavia priva di conclusione certa, sta nel dato di fatto che la moglie in Daves, pur piacevolmente affascinata per un motivo o l’altro dal discorso di Wade sugli occhi verdi delle donne, non pare avere niente da tenere nascosto o di cui vergognarsi, diversamente dalla moglie in Mangold.
Venendo ora alla barista e prostituta tubercolosa che serve l’whiskey alla squadra di banditi a Bisbee, interpretata nel film di Daves da un’ottima Felicia Farr, Emmy, questo è il suo nome, un diminutivo di carineria nei suoi confronti data la sua dolcezza, essa ha una sporadica e veloce relazione erotica con Ben Wade e ne è contenta, perché così avrà, come dice malinconicamente, qualcosa di bello da ricordare, per cui sognare – non senza significato è il nome del locale in cui essa cantava e in cui ricorda di averla vista Ben Wade, ossia l’ Eldorado, evocante il dorato paese esistente solo nel sogno più bello. L’unica non ripetibile relazione con Ben Wade, di cui si è innamorata immediatamente, ha lasciato il segno in lei sebbene abbia avuto brevissima durata, si tratta di un amore fisico che però in lei è accompagnato da affetto come nelle sue parole, quasi essa sia riconoscente all’uomo per quello che le ha dato non solo fisicamente, ma anche affettivamente, come lei crede e comunque per quanto riguarda i propri sentimenti per il bandito, cui apre anche la porta della diligenza che lo porterà via dopo che l’hanno arrestato. Tale ex cantante è una donna dolce che anche il bandito ricorderà e cui invierà un prezioso regalo di perle, perché essa non dimentichi e per non dimenticare appunto neppure lui, senza tuttavia volersi fermare con questa donna con cui non sogna di formare una famiglia. Ed è impossibile non riconoscere in tali perle che le donerà il bandito un’associazione, per quanto molto in sedicesimo, alla pioggia diamantina che cade in festeggiamento sulla moglie in Daves. In aggiunta c’è un ulteriore immagine di questa donna che fa da pendant anch’essa, sempre in sedicesimo e con tinte di tristezza, di rinuncia, con quella della moglie sotto la pioggia concreta e metaforica, certo non radiosa come quella: la donna cammina ripresa prima frontalmente, poi di spalle nello spiazzo antistante il bar e si ferma, immobile, quasi una statua, nello spazio completamente solitario per seguire con lo sguardo la diligenza che porta via Ben Wade, quasi a proteggerlo seppure in lontananza con il suo affetto. È vestita di scuro nel bianco e nero, di fronte alla vasta campagna aperta, mentre la polvere bianca suscitata dall’attrito delle ruote della diligenza sulla terra fa scomparire la stessa carrozza come nel nulla e con essa Ben Wade, come se il suo incontro con il bandito che essa amerà per sempre finisse in polvere e vivesse solo nella mente di Emmy come motivo di sogno di un amore impossibile. La polvere in cui scompare la diligenza associa, nel livello un iversale, l’umanità tutta di cui resta appunto solo la polvere come nel simbolo biblico del libro della Genesi, quando Dio maledice l’uomo e lo scaccia dal giardino dell’Eden condannandolo al lavoro duro e alla morte. Così essa ha nel film il suo momento di celebrazione, a dimostrazione che anche una donna che abbia scelto di fare la cantante e altro in un saloon o simile, ciò di cui ha un nostalgico ricordo, e non il ruolo della moglie e madre di famiglia, possa avere un carattere dolce e sognare ciò che non ha più e non ha avuto, sia ormai il saloon, sia essere la donna di un solo uomo da amare esclusivamente.
Quanto alla prostituta e cantante nel film di Mangold la quale pure ha un rapporto sessuale veloce con Ben Wade, essa, ugualmente malata di tisi, è molto diversa da Emmy. Si chiama Emma, senza diminutivo, e non ha lavorato all’Eldorado, ma in un locale non collegato nel nome al sogno e alle belle cose, bensì di Redville, luogo altrettanto inesistente come l’Eldorado, ma il cui colore rosso rimanda alle zone a luci rosse della prostituzione così chiamate negli Stati Uniti a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, una città simbolo del vizio dunque. Quando Ben Wade le propone di saltare con lui dalla finestra della stanza per cambiare entrambi vita e vivere assieme in un pueblo, un villaggio al confine con il Messico, dall’altra parte del fiume, la donna dileggia con ironia e addirittura senso di superiorità l’idea e anzi poi si mette a ridere apertamente, prendendo in giro Ben Wade per la sua proposta che le appare assurda e in parte comunque inferiore alle sue attese o pretese. In questo caso Mangold sottolinea come l’uomo, sebbene ormai escluso dalla norma civile e legale, sogni una vita diversa, ossia di cambiare per il possibile tipo di esistenza e di fermarsi in un paese con una donna, ma la donna, questo tipo di donna, non è capace di cambiare vita, di saltare con lui da quella finestra, ossia di sognare un amore diverso da quelli cui è abituata – sempre secondo ciò che trasmette il film. Il bandito dunque, pur fuorilegge, è capace di sognare una vita quasi normale sebbene con una prostituta, ciò in cui consiste, nel contesto, il suo errore e l’impossibilità di realizzazione, vista la reazione della donna alla sua proposta. Come sappiamo, anche in Daves Ben Wade sogna una vita diversa, ma non con Emmy per quanto dolce donna dell’Eldorado, bensì con una donna come Alice, moglie di Dan, la quale rappresenta il riferimento positivo del femminile a livello della famiglia e della società. La piena risata scatenata in Emma quale risposta alla proposta comunque positiva di Ben Wade che vorrebbe fermarsi nel pueblo messicano con lei, luogo dove non è ricercato dalla Giustizia, rievoca, seppure in una lontana eco, la tremenda risata, sguaiata e ben più estesa, della pure prostituta Lola interpretata più che perfettamente dalla bravissima attrice tedesca Marlene Dietrich (Schöneberg 1901-Parigi 1992) nel suo più importante e più bel film Der blaue Engel (1930), L’angelo azzurro, di Joseph von Sternberg (Vienna 1894-Hollywood 1969), quando Rath, professore di Liceo, nell’interpretazione a dir poco sublime di Emil Jannings (Rorschach CH 1884-Strobl A 1950) le chiede di sposarlo. Due risate, seppure su piani diversi, di spregio da parte di due affini paralleli personaggi femminili dall’ottica realistica in risposta a una proposta maschile capace di sognare la bellezza degli affetti, della vita pur nella scelta discutibile.
Due prostitute, in Daves e in Mangold, interpretate diversamente anch’esse.
Ci occupiamo adesso in particolare dei personaggi maschili. Già Daves evidenzia la scarsa solidarietà del gruppo cosiddetto positivo: tutti coloro, che avevano promesso di aiutare Dan Evans contro i banditi nel viaggio a Contention e nel tragitto a piedi alla stazione, lo abbandonano perché al di là delle loro parole non se la sentono di rischiare la vita a fronte di una banda che per liberare il suo capo è disposta a uccidere chiunque si contrapponga. L’unico che resta con Dan è il sopra citato Alex Potter che, a Contention, mentre sta di guardia fuori dall’albergo, vedendo un bandito sul tetto di una casa pronto a uccidere Dan, fa in tempo ad avvertirlo e gli salva così la vita prima di essere colpito da Charlie Prince e poi impiccato al lampadario della hall. Anche Butterfield, il funzionario della Ferrovia, dichiara di lasciare l’impresa sconvolto dopo aver visto Alex Potter, a monito per chiunque volesse aiutare Evans, appeso al lampadario e consiglia a Dan di andarsene anche lui stesso, essendo disposto a corrispondergli ugualmente i duecento dollari pattuiti. E Dan verrà aiutato non dagli uomini che lo accompagnavano e da quelli che Butterfield ha reclutato a Contention, ma appunto dal malvivente, che pare avere, nella fattispecie, un cuore, anche una moralità, accettando alla fine anche di farsi processare ed eventualmente condannare addirittura a morte pur di aiutare Dan Evans.
Nel film di Mangold la presentazione degli uomini ingaggiati dallo sceriffo per far fronte ai banditi che si prevede vengano a salvare il loro capo, è ancora peggiore. Anch’essi, sceriffo in testa, abbandonano Dan quando vedono il tipo di banda e la quantità di cittadini che si sono aggiunti a favore della banda credendo nella lauta ricompensa di duecento dollari promessa, ingannevolmente da Charlie Prince, a tutti coloro che uccideranno chi aiuti a mettere sul treno per Yuma il suo capo, cittadini per così dire onesti, che in ogni caso vivono nella legalità a quanto sembrerebbe in tutta superficie, entro regole stabilite dalla Legge, come dice lo sceriffo a Ben Wade, rimarcandogli che ovunque si vive nella legalità, che piaccia o no al bandito, affermazione che è in contrasto con la realtà che mostra pochi cittadini e meno che mai Autorità che siano onesti, a partire dallo sceriffo stesso. Molti sono di fatto subito disposti a ucciderne anche due di persone oneste per il denaro offerto da Prince che in ogni caso, pur spietato assassino, mostra di saper essere fedele al capo: dopo che Ben viene arrestato e che Charlie si accorge a suo rischio che non è lui che sta nella diligenza come aveva creduto cadendo nella trappola orchestrata dallo sceriffo a Bisbee, un bandito del gruppo, osservando che Contention è troppo distante, gli dice che il capo aveva commesso un errore perdendo tempo con la donna al bar, e allora Prince pone la significativa domanda retorica, se abbia già scordato tutto quello che il capo aveva fatto per loro, così decidendo in qualità di braccio destro del boss di andare a liberarlo con il resto della banda a Contention, ossia rischia la vita in quanto gli è grato e richiama all’ordine anche gli altri banditi che in ogni caso lo seguono. Quando però lo sceriffo di Contention, che pure aveva accettato per altro con fare da grande rappresentante della Legge di collaborare con altri due uomini a mettere Ben Wade sul treno per Yuma e a proteggere la scorta contro i banditi, si ritira dalla cooperazione e se ne va perché non vuole essere ammazzato, Dan gli tira dietro la stella di sceriffo di cui all’apparenza non è all’altezza – un po’ come Will Kane in High Noon quando getta a terra alla fine la stella e lascia Hadleyville. Di fatto quando lo sceriffo di Contention e i suoi uomini si arrendono e, all’uscita dall’albergo, posano le armi al suolo e alzano le mani secondo gli ordini dello sceriffo che mostra loro come fare per non rischiare, i banditi li uccidono immediatamente non fidandosi di tali persone e uccidono anche altri cittadini per seminare il terrore. Qui Mangold evidenzia, per quanto implicitamente alla concatenazione delle immagini, come sia scarsa l’intelligenza del rappresentante della Legge che crede di avere a che fare con persone domestiche e perbene che rispettino la sua – disonorevole – resa. Un dettaglio opportuno a conferma della qualità di un tale sceriffo a capo di una città: quando William ha visto i banditi in lontananza arrivare a Contention e ne dà subito notizia al padre in albergo, lo sceriffo gli chiede quanti fossero, e il ragazzo dice “sette o otto”, lo sceriffo facendosi grande con il ragazzino gli ingiunge, con tono perentorio come di chi si senta importante e superiore, di decidere se sette o otto, allora viene evidenziata nel film di nuovo la sua attenzione alle precisioni meno importanti, precisazioni per altro richieste a un ragazzino – non fa la domanda a nessun adulto e Butterfield, nelle immediate vicinanze, gli dà la risposta, “sette”, in quanto ha udito la domanda e ha potuto vedere più da vicino quanti fossero i banditi in arrivo – in ogni caso lo sceriffo non va a vedere di persona alla finestra quanti siano i banditi. Viene presentato malissimo anche il cacciatore di taglie, interpretato da un ottimo Peter Fonda (New York 1940-Los Angeles 2019), ossia McElroy reclutato dall’agenzia dei Pinkerton che ricerca i criminali per conto della Ferrovia- Una breve nota sul nome dell’Agenzia: fondata a metà dell’Ottocento negli Stati Uniti da uno scozzese, aveva come logo un occhio aperto come simbolo di una vigilanza incessante – per altro sventò l’assassinio del Presidente Abraham Lincoln. Tuttavia nel film bastano alcuni banditi per ammazzare tutti gli agenti Pinkerton e Charlie Prince dice con sufficienza di odiare i Pinkerton, in una più che ironica rappresentazione del mito costruito – a suo tempo – dall’Agenzia stessa su di sé, mito pagato a carissimo prezzo da coloro che si facevano proteggere dagli agenti appunto Pinkerton, nome che Mangold ha lasciato senza alcuna modifica ritenendo che non ce ne fosse bisogno. E qui c’è implicitamente una visione non troppo positiva delle agenzie private alla caccia dei delinquenti, con riflessi non troppo nascosti sulle forze dell’ordine a livello istituzionale – sulla poca o anche nulla credibilità delle Autorità ci sono riferimenti ovunque nel film. Al fatto che l’agenzia a nome Pinkerton nel film assoldi veri e propri delinquenti di ultimo rango come McElroy c’è poco da aggiungere. Tale ex cacciatore di taglie, ossia di denari, si vorrebbe ritenere un giustiziere legalmente autorizzato essendo pertanto sempre nel giusto quando uccide i criminali ed essendo invece nella sua personalità un bieco assassino che uccide per denaro molti uomini, anche donne e bambini piccoli indiani, come quando li ha gettati ancora vivi e piangenti in una fossa, come riferisce Ben Wade quasi a sottolineare piuttosto esplicitamente come non vi sia differenza tra i delinquenti e le persone che credono di poter fare qualsiasi cosa dato che operano ufficialmente nella legalità credendosi onesti per questo. Così, quando il bandito lo riempie di percosse perché ha insultato la madre e lo butta poi, ancora vivo, giù da una rupe come fosse immondizia o un rottame, non si può evitare di non essere troppo dispiaciuti, come è nelle finalità del messaggio del regista. Per altro questo personaggio, di pessime e arroganti maniere, ha insultato anche Charlie Prince durante l’assalto alla diligenza, dove era di scorta, citando il suo soprannome, ossia Princess, Principessa, sentendosi in diritto di offendere tutti impunemente. Qui c’è un cenno, molto attuale, alle persone che disprezzano altri per le loro ipotizzate tendenze sessuali come fossero degne di essere offesi liberamente, questo senza assolutamente che Mangold esprima un giudizio positivo sulle citate tendenze come vedremo in dettaglio – un approfondimento specifico sul rapporto tra Charlie Prince e Ben Wade, in contrasto con l’insulto di McElroy, più avanti nell’analisi, qui basti ricordare il dato di fatto che Prince, dopo l’offesa alla madre e a lui stesso come Princess, ossia come omosessuale, spari a McElroy nello stomaco e stia per ucciderlo, mostrandogli comunque di non avere il carattere della Principessa, ossia di una dolce e tremula donna.
Riprendendo dopo la digressione: quando Tucker, l’uomo al servizio di Hollander, il proprietario terriero perbene, e incaricato di fare per lui il lavoro sporco, delinquenziale, viene ucciso da Ben Wade con una lunga forchetta sottratta durante la cena a casa Evans e piantatagli nella gola, non si può essere, di nuovo, troppo dispiaciuti. Come accennato, tali effetti emotivi sono suscitati intenzionalmente dal regista per evidenziare come, nel messaggio del suo film, non ci sia soverchia considerazione per coloro che dovrebbero rappresentare la Giustizia e la Legge, la legalità, spesso uguali ai fuorilegge se n on anche peggiori dei delinquenti che sono presentati sempre almeno come esenti da ipocrisie. La più notevole differenza comunque fra i buoni e i cattivi in Mangold è la scarsa capacità di tenere fede a qualsiasi impegno da parte di molti cosiddetti giusti, che appaiono immediatamente corruttibili per denaro e anche pronti a uccidere chiunque, sembrando quindi solo delinquenti mancati, non persone oneste, mentre i delinquenti sanno essere fedeli al capo, ossia non si tirano indietro nell’eseguire i suoi ordini che portano a termine anche se non sempre condivisi, insomma hanno nel film di Mangold qualche qualità, come pure nel film di Daves sanno rischiare la vita pur di essere fedeli al capo. Si tratta di gruppi sociali negativi, quelli dei banditi, che sono tuttavia, più dettagliatamente in Mangold, ma appunto anche già in Daves seppure meno marcatamente, non del tutto privi di qualche qualità che i cosiddetti giusti non hanno in egual misura. In aggiunta al proposito: il bandito Ben Wade, in Mangold e non in Leonard e in Daves, ha letto l’intera Bibbia, dal cui libro dei Proverbi cita diversi passi importanti, e, pare, altri libri ed è anche un artista, disegna bene, curando quest’arte ovunque gli sia possibile. In altri termini: il capo dei banditi ha tratti da intellettuale e da artista, ciò che non ha nessun altro dei personaggi perbene del film. Un bandito che, accanto al potere assoluto e senza scrupoli che detiene nel suo gruppo, ha qualità che sono in ogni caso ai vertici di quanto si possa desiderare per l’umanità: cultura e arte. Forse Mangold ha simpatia per i delinquenti? Certamente no secondo quanto sta nel film – tali personaggi hanno la chiarissima identità di assassini e predoni. C’è solo la comparazione con i cittadini per bene, le Autorità legalmente costituite e queste persone, che in un’ampia percentuale non sono molto migliori dei delinquenti e anzi hanno, in più, tratti di ipocrisia, come accennato, che i delinquenti, pur restando tali, mostrano di non avere – nessuno di loro vuole spacciarsi per brava persona.
Importante nei due film è il tema dell’alleanza fra maschi che stanno su sponde opposte come i protagonisti, la sponda dell’onestà e della disonestà, del bandito e dell’uomo che lavora e rischia la vita per portare denari onesti a casa, nemici che invece di odiarsi finiscono per allearsi nell’onestà pur con mete opposte – anche in Leonard, dove il delinquente alla fine, esitando nell’abbassarsi per consentire a Charlie Prince di uccidere Scallen, aiuta il vicesceriffo che uccide il suo amico. Dunque nel tempo trascorso assieme nella stanza d’albergo di Contention i due uomini si rivelano alcuni fatti personali che nessun altro conosce e questo forma una base per la loro alleanza, in quanto si scoprono uomini che cercano di vivere la vita ciascuno nel migliore dei modi secondo la propria visione del mondo pur diversa. Base che in Daves ha al suo centro la figura della moglie di Evans e che in Mangold ha alla base la conoscenza fra i due uomini, il cuore di Ben Wade che si coinvolge quando sente il discorso che Evans rivolge al figlio prima di dirigersi alla stazione, come un suo testamento, esplicitandogli ciò che dovrà fare in qualità di futuro responsabile della salvaguardia della famiglia e dell’azienda paterna, anzi in qualità già di uomo che vivrà nell’onestà come ha appreso da lui, discorso che il figlio, superando il pudore maschile nell’espressione dei sentimenti più veri, accetta commosso dicendo al padre di volergli tanto bene – di fatto contravvenendo poi per affetto all’ordine di stare con Butterfield che lo riporterà a casa dopo che sarà finita in un modo o in un altro l’azione pericolosa, cercando inutilmente, in tutti i modi anche non poco rischiosi, di aiutare il padre e non uccidendo a sua volta, pur potendolo fare, Ben Wade che ritiene responsabile della morte del padre. Non lo uccide pur stando per sparargli mentre Ben Wade gli offre il petto per facilitargli l’azione, in quanto dispiaciuto profondamente di quanto è accaduto all’uomo onesto e nuovo amico diverso dagli ipocriti perbene – Dan gli confessa alcune verità, non è un ipocrita che si spaccia per eroe diverso da ciò che è –, così da salire sul treno ugualmente sebbene nessuno lo costringa ormai, essendo morto Dan Evans. Non si può sottovalutare il dato di fatto il dato di fatto che il giusto, l’uomo buono e democratico, muoia, non possa portare avanti la sua onestà e buona fede. Nel caso si può ritenere che sia il figlio a farlo e in effetti William vorrebbe uccidere il bandito, ma desiste pur dispiacendosene perché segue la via segnata nella legalità dal padre. Certo, le cose stanno così: il figlio ha imparato a essere onesto dal padre, che tuttavia, ribadendo, è morto ammazzato per essere onesto. Allora Dan nel film è un martire dell’onestà? Ci vogliono martiri per essere di esempio per l’onestà? Se il figlio vivrà nell’onestà, è per il grande affetto che porta al padre prima che per l’onestà in sé. Ci sono oggettivamente dubbi sul concetto di onestà per come è trattato in seno al messaggio del film. Certo, il fatto che l’onesto muoia e che il figlio non uccida il bandito ritenuto responsabile della morte del padre anche se non lo ha ucciso lui, potrebbe voler dimostrare che l’onestà abbia comunque il sopravvento sulla disonestà, sull’illegalità, sulla violenza, questo come eredità morale nel figlio. Ma muore anche doc Potter, ciò che nel contesto si aggiunge alla morte finale di Dan Evans e in infinitesimale parte alla morte di Charlie Prince che, in ogni caso, nel contesto lascia un po’ di amaro, dispiace un po’ in quanto uomo fedele a Ben Wade, affezionatissimo e capace di sentimenti per il suo capo – dalla piazza di fronte alla finestra della stanza d’albergo in cui si affaccia Ben Wade, lui chiede al boss se stia bene, ossia si preoccupa del suo stato psicologico, fisico. Un individuo sfortunato, come appare, Charlie Prince, avendo avuto come maestro la persona sbagliata, implicitamente non avendone avute altre di migliori, un padre e una madre provvidi, come si inferisce, ciò che non toglie che resti un assassino ormai irriducibile, irrimediabile. In questo contesto in cui si affollano varie stimolazioni su personaggi e temi, sull’onestà in particolare, sorge un’ipotesi che può essere tracciata più nel profondo. Oltre a quanto si vede con chiarezza esplicita in tutto il film, una risposta che Dan Evans dà a Ben Wade durante il viaggio avventuroso e che riguarda il fatto che rischi la sua vita e anche la sorte della sua famiglia solo perché la Ferrovia ha perso dei soldi, offre una spiegazione ulteriore per la motivazione della scelta: perché forse non vuole che gente come il bandito se ne vada in giro impunemente, ossia Dan rischierebbe tutto quello che ha per un motivo che rientrerebbe nella volontà di farla pagare a persone come Ben Wade, audaci pur nel male, una motivazione personale dunque non troppo diversa – sebbene comunque diversa – dalla vendetta, dalla rabbia che vi siano persone capaci di essere incuranti della Legge diversamente da lui e che possano vivere impunemente, una motivazione psicologica dunque che – nel profondo – non è direttamente riferibile al concetto dell’onestà in cui ritiene, a metà come appare visibilmente, di muoversi Dan Evans. Poco prima di morire Dan dice al figlio che deve ricordare che suo padre è stato l’unico a scortare il bandito quando nessuno lo ha voluto fare, altra motivazione personale, tanto più che se non fosse stato agevolato da Ben Wade non ci sarebbe riuscito affatto. Dan Evans non è un grande combattente, un grande audace, ha perso la gamba in una ritirata a causa di un colpo partito per sbaglio da un compagno che lo ha raggiunto a un piede.
Questo dell’onestà è nodo psicologico, molto intricato, del quale Mangold, al di là di ogni visione di superficie valida nell’ovvietà e nelle illusioni per la convivenza civile, è molto interessato come emerge nel film, dove il tema delle motivazioni profonde dell’onestà, posto in sordina, testimonia come flash del suo sguardo disilluso sulla qualità dell’umanità perbene, come tema di riflessione sulla verità psicologica della personalità umana – vediamo appunto ovunque all’ingrandimento nel film come i cittadini perbene non di rado non siano troppo diversi dai delinquenti, come McElroy, anche Bones incontrato nel tunnel quando vorrebbe presentarsi come persona onesta che voglia giustizia per il fratello ucciso da Wade, fratello che era solo un baro, un disonesto implicitamente, un uomo che Ben Wade definisce una carogna. Per altro uno degli onesti, dopo la riuscita fuga del gruppo fuori dal tunnel, tiene nella fondina al cinturone l’inconfondibile revolver sottratto a Ben Wade prima della sua fuga quando era stato messo al palo e torturato dagli onesti, revolver che Charlie Prince vede quando seguendo le piste del gruppo giunge nel tunnel così uccidendo molte di quelle brave persone. Tutto ciò appunto in un nodo fatto di onestà e disonestà difficilmente districabile, così come è presentato nel film di Mangold e solo nell’ipotesi tracciata testé esprime il suo senso più verace. Al proposito: sia il figlio William che Butterfield sono in ogni caso sorpresi alla fine del fatto che il bandito Ben Wade salga sul treno per conto proprio e consegni la sua arma alla guardia, questo in onore e tributo al sacrificio di Dan Evans, che Wade ha avuto modo di apprezzare per la sua personalità e che ha aiutato anche per compassione del suo stato lasciandosi arrestare, anzi per così dire arrestandosi da sé. Importante è ricordare al proposito la lettura della Bibbia in Wade, dalla quale trae quegli insegnamenti positivi che non ha ricevuto dal padre e dalla madre, come quando, a proposito della convinzione di McElroy di avere ucciso sempre per giusta causa chi se lo meritasse, cita il secondo dei biblici Proverbi 21, secondo il quale tutte le vie dell’uomo sembrano rette ai suoi occhi, ma è il Signore a pesare i cuori – difficoltà di comprendere in generale da parte degli umani le regole stesse che si sono venuti creando nella loro esperienza di vita e sappiamo anche che McElroy crede addirittura di essere nel giusto, sbagliando completamente giudizio su se stesso, sul concetto di legalità, di giustizia, di onestà. Ribadendo: Mangold, come è sua caratteristica precipua in generale e in particolare in questo film, offre un rappresentazione esplicita e implicita di quella che nel suo giudizio è la realtà psicologica umana per come si manifesta nei comportamenti individuali e nelle regole sociali, mostrando come in non pochi casi, tra gli altri in quello che riguarda il citato concetto di onestà, non vi sia differenza profonda fra delinquenti e uomini di cui si serve una società che si vuole considerare democratica. Riguardo alle carenze che inficiano ancora la legalità in non piccola parte secondo il film di Mangold, Dan Evans durante l’esperienza relativa all’incarico che lo porterà a essere ucciso, dice in ormai totale disillusione che per la sua gamba amputata gli hanno dato un rimborso della stessa cifra stabilita per l’incarico di scortare il bandito, cifra che ora sa gli sia stata elargita perché i rappresentanti della legalità hanno così potuto salvare se stessi tirandosi indietro, come ha fatto appunto Butterfield che, quando si ritira dall’affrontare i banditi, è disposto a dargli i duecento dollari pattuiti, per così dire a pagarlo, anche se o se rinuncia all’incarico visto il rischio che corre e ciò non tanto per Dan, quanto per se stesso, un pagamento che, al di là della buona azione che sembra e che in parte anche è, suona però nel sottofondo come una specie di tentativo di corruzione finalizzato a giustificare il proprio ritiro dall’impegno preso. Una critica sociale molto forte dei valori che gli umani si sono costruiti, come pare, a proprio uso e consumo secondo i casi.
Segue ora per il film di Mangold un preambolo introduttivo alla preannunciata trattazione di alcune simbologie importanti e profonde, preambolo relativo a Ben Wade, al rapporto fra Ben Wade e il suo uomo di fiducia, Charlie Prince, detto Princess per l’eleganza della figura, anche del vestimento rispetto agli abiti degli altri banditi, del portamento e anche per la sua devozione al suo capo cui è sempre vicino e che egli venera come un maestro per quanto fuori dalla Legge.
Veniamo dunque al riassunto della relazione. Charlie, come è già stato sottolineato, ha un posto nel proprio cuore per il suo capo, per gratitudine e per ammirazione, per aver dato significato alla sua vita, ciò al contrario di Ben Wade che non ha un affetto per lui come per nessun altro della banda, di cui, come dice, conosce la bassezza anche per esserne il capo egli stesso. Ad esempio, quando Prince gli restituisce il cappello, che ha recuperato dalla testa di colui che doveva essere preso per Wade nel trasferimento a Contention e il capo lo ringrazia dalla finestra dell’albergo in cui si trova, Prince si emoziona a tal punto che dalla soddisfazione di avere fatto piacere al capo così da averne ricevuto il suo ringraziamento e riconoscimento personale, abbassa la testa sul petto per nascondere il suo sorriso di compiacimento, rivelatore dei suoi sentimenti verso il suo maestro, una gioia che in ogni caso vuole tenere solo per sé quasi avendone pudore. Più volte Prince presenta Ben Wade dicendo agli altri che avevano davanti a sé niente meno che Ben Wade, grande persona per lui, capace di incutere terrore e in effetti è il più grande e temuto bandito, ma sempre solo un bandito che Prince idolatra e considera appunto come suo maestro, non avendo avuto come più sopra, implicitamente e verosimilmente, nella sua giovane vita altri modelli esistenziali migliori cui attenersi, nemmeno genitori che lo abbiano amato ed educato all’onestà.
Memorabile è la spazialità relativa all’uccisione di Charlie Prince da parte di Ben Wade – in Daves Dan Evans, una volta sul treno afferra il revolver scivolato sul pavimento del vagone porta bagagli e fredda con un colpo Charlie Prince che ancora insegue il treno per uccidere Dan e salvare, come crede, il capo che però non ha più alcun interesse per lui né per gli altri componenti della banda. In Mangold, quando pare che si siano salvati entrambi i protagonisti – Ben è già sul treno e i due si sorridono ormai in piena alleanza, Dan si trova a spalle girate imprudentemente alla banda di delinquenti –, allora Charlie giunge risoluto a grandi passi ed elimina colui che ha preso il suo posto nel cuore del capo sparandogli con la sua Colt tenuta a braccio teso, più volte alla schiena e frontalmente in una continua successione di colpi, con ciò abbattendolo al suolo, morente. Poi passa al boss il revolver maledetto a sua volta passatogli da altri banditi con un lancio e, sapendo di averla fatta grossa, dice con un tono di voce che vorrebbe essere complice del capo nella preferenza per Dan, che per essere questo un contadino da una gamba sola, era one tough son of a bitch, un tosto figlio di buona donna (eufemisticamente nella traduzione qui), epiteto utilizzato non come insulto come potrebbe forse sembrare a prima vista, ma, appunto nel tono e nel mezzo sorriso, come un complimento espresso in modo cameratesco, maschile, di riconoscimento del valore. Il capo però neppure gli risponde – come già quasi sempre – e prepara il suo speciale revolver maledetto che gli ha restituito proprio Charlie al momento. Charlie comunque, intuendo nel profondo ciò che ormai non può non accadere avendo egli trasgredito l’ordine del capo di non sparare a Dan Evans e in più sapendo quanto Wade ci tenesse a Dan Evans, spera ancora che il capo non si comporti come con Tommy Darden – vedi più sopra. Ribadendo: tuttavia è proprio lui stesso a consegnare al capo la sua arma, come in un presentimento, dando a Ben la decisione per il proprio destino, la propria vita che senza di lui non avrebbe più alcun senso – per altro se il regista avesse voluto non rimarcare questo dettaglio, avrebbe potuto far consegnare l’arma da un altro bandito, ciò che non ha fatto, gli altri banditi solo si passano a lanci l’arma per consegnarla con l’ultimo lancio a Charlie di cui conoscono il particolare legame con Wade, perché la lanci direttamente lui al capo. Ferito interiormente dalla scelta del nuovo amico da parte di Wade, si allontana pensoso girando le spalle al capo come in attesa – quasi come Dan ha girato le spalle al pericolo –, si gira però verso Ben come attratto da ciò che stava per accadere e in tempo per vedere Ben Wade che gli spara per ucciderlo. Charlie estrae a sua volta l’arma per abitudine a difendersi, ma senza convinzione, non è come al solito più veloce e abile di tutti nello sparare, spesso anche camminando e in distanza a soggetti anch’essi in movimento. Forse al momento si trova in postura infelice dovendosi girare, ma soprattutto non è rapido tiratore come sempre, quasi non avesse l’intenzione di uccidere il boss, mentre questo lo uccide senza scrupoli, né considerazione della sua sofferenza per non essere più il primo nel suo cuore – dove per altro, come già accennato, non c’è mai stato altro che nell’illusione di Charlie. Questo non cade al suolo e, pur morente, resta in piedi con l’arma abbassata nella mano sinistra – Charlie è un ambidestro, il boss è un destrimano, spara sempre con la destra e disegna anche con la mano destra –, potrebbe ancora con tutto agio sparare al capo mentre è impegnato a uccidere tutti i suoi uomini per vendicarsi, ingiustamente, di loro per la morte del suo nuovo amico, ma non lo fa, troppo forte è il legame che sente ancora verso Ben. Infine è in piedi solo Charlie Prince che attende il capo, verosimilmente ormai per ricevere da lui il colpo finale, almeno questo dedicato solo a lui. In un profondo e molto speciale gioco simbolico che l’immaginazione artistica rappresenta al meglio per la relazione privilegiata con l’inconscio, Ben si avvicina a Charlie ferito a morte il quale aspetta ormai il colpo di grazia dal suo boss guardandolo dritto e fisso negli occhi. Ben Wade lo tiene stretto a sé e gli spara con il revolver premuto sul petto dritto al cuore, dopo di che Prince viene lasciato cadere da Ben Wade a terra ormai senza vita, come un sacco di ossa. Ben gli riserva il colpo al cuore per ucciderlo, certo – potrebbe però sparargli anche da una certa distanza –, ma sceglie di sparargli da vicino anche nel simbolo, come per spezzargli esplicitamente proprio il cuore, per rifiutare Charlie Prince definitivamente, per non lasciargli così nessuna illusione di amicizia esclusiva tanto forte da avere la sfumatura erotica in Charlie, quale si può manifestare da parte dei soldati verso il capo carismatico. Così resta solo lo stretto abbraccio mortale che è reale, non illusorio, ciò mentre Charlie non oppone, molto significativamente e quasi femminilmente, alcun tipo di resistenza, né dice alcunché, lasciando parlare per l’ultima volta i suoi occhi penetranti in quelli del suo capo.
In questo rapporto speciale, e anche commovente per certi versi, dell’uomo di fiducia verso il suo boss, si può individuare, in verità molto chiaramente – sto riferendomi a questo film e non ad altri film di Mangold – un messaggio, implicito al contesto e più generale, riguardante le possibili relazioni fra persone dello stesso sesso, nella fattispecie fra maschi. Charlie Prince è affezionatissimo al suo capo, di fatto rimane visibilmente male quando Ben Wade guarda con interesse Emma e resta nel bar di Bisbee quando sarebbe più opportuno che seguisse il resto della banda, nonché alla fine della vicenda uccide Dan Evans per una sorta di gelosia verso colui che ha preso il posto che prima era suo vicino al cuore o nel cuore del capo, questo solo nell’illusione di Charlie, ribadendo ancora. Ben Wade fa piazza pulita di un tale attaccamento di Charlie nei suoi confronti – e di cui già agli inizi del film era infastidito, prima di conoscere Dan – addirittura uccidendolo. Nella sua amicizia verso Dan Evans e viceversa non ci sono speciali attaccamenti, si tratta di una normale alleanza fra maschi come sono comuni da sempre, niente sfumature erotiche di nessun tipo che ci sono invece per quanto in parte come sopra, nel personaggio di Charlie, la cui morte si proietta anche su questo tipo di possibili relazioni non ritenute tali, da Mangold in questo film, da poter esistere, questo nell’inequivocabile messaggio filmico. In altri termini: nella morte di Charlie agìta da Ben Wade, che sa dell’attaccamento di Charlie nei suoi confronti, come vedremo, c’è anche, implicito ma inferibile, il giudizio negativo su possibili rapporti che vadano oltre la normale alleanza fra maschi, il rifiuto insanabile di essi da parte di Ben Wade è comprensibile anche nei riferimenti espliciti ai suoi rapporti con donne nei vari locali malfamati, rapporti non sentimentali, ma solo fisici. A conferma, Wade disegna Emma, cui proporrà di vivere con lui, ritraendola nuda dal retro, senza volto pertanto e senza piedi, con la regione glutea al centro delle sue attenzioni, ciò che rivela molto chiaramente il tipo di rapporto che avrebbe potuto instaurare con lei – e con la donna in generale –, solo fisico, un rapporto a metà quindi e privo della parte più importante, quella dei sentimenti eventuali per la persona, questo in contesti che non lasciano dubbi, ciò che in ogni caso sottolinea la sua preferenza per le donne. Non si tratta tuttavia di un pensiero tradizionale in quanto la tradizione mostra varie possibilità di scelta sessuale per i maschi, esaltate nell’epoca presente, bensì si tratta di una presa di posizione precisa, di una scelta che elimina o non considera valide le altre possibilità pure esistenti.
Perché quindi dedicare addirittura un importante Leitmotiv a tale problematica? Mangold è regista che dedica nei suoi film, come è noto e già accennato, molto del suo interesse all’approfondimento piscologico dei vari tratti della personalità umana senza per altro esimersi dal proprio giudizio su di essi, fino a far finire in questo film le illusioni di Charlie nel rifiuto peggiore da parte di Ben, che così mostra di averlo solo sopportato e che lo uccide senza pietà per toglierselo, non solo per vendetta – che volesse toglierselo in quanto lo infastidiva precede, come accennato, la conoscenza di Dan Evans, come vedremo in maggiore dettaglio. Ben Wade rimane l’individuo spietato che è sempre stato e spontaneamente orientato verso il sesso opposto come è pure sempre stato ed è anche l’unico protagonista tra i tre protagonisti – ossia se stesso, Dan e Charlie, pure protagonista cui è dedicato un Leitmotiv in aggiunta – a restare in vita, che può pertanto proseguire nel suo percorso esistenziale e, forse, migliorare, ricordiamo che ha dato spazio dentro di sé per la prima volta con Evans alla compassione, sentimento che aveva sempre evitato, come dalle sue parole quando dice a Dan che basta fare una buona azione una volta e si diventa buoni, ciò che lui non ha mai avuto modo di volere prima di conoscere una persona come Dan. E qui si presenta, come anche altrove in questo film, di nuovo la visione disillusa di James Mangold: difficile rimediare agli errori gravi nella propria esistenza, anche nelle migliori intenzioni. Certo, nella consegna della propria arma al funzionario della Ferrovia, Ben Wade si libera dalla maledizione dell’arma, delle armi, ma la consegna dell’arma si verifica dopo una strage compiuta da Ben Wade. Facendo un’ipotesi plausibile, se davvero la compassione avesse esercitato un inizio di cambiamento positivo, il bandito, forse, non avrebbe ucciso Charlie, il suo fedelissimo, avrebbe compreso e avuto pietà del suo attaccamento così intenso, lo avrebbe perdonato insomma – ma Ben Wade è esperto di Bibbia, non di Vangeli –, avrebbe dunque trovato altri mezzi, nel film, per liberarsene, così come non avrebbe sterminato tutta la sua fedele banda, e questo proprio alla fine del film, dove nulla ha più seguito in un finale per così dire aperto. In altri termini: non c’è alcun segno inequivocabile che possa far pensare a un inizio di una nuova esistenza nel bene – la volontà di vendetta ha avuto ancora il sopravvento, a comprova che il passato non venga superato che molto difficilmente, come eccezione alla regola – eccezioni alla norma esistono sempre.
Giunge adesso, dopo il preambolo e come preannunciato quale conclusione di questo studio, la particolarmente complessa analisi semantica relativa alle intenzioni e anche premonizioni e attrazioni inconsce e semi inconsce sparse nel film, iniziando dalla decisione riguardante il dato di fatto a livello simbolico secondo il quale Ben Wade avesse, per così dire, già premeditato di liberarsi dell’ignaro Charlie Prince e anche della vita di bandito prima di conoscere Dan Evans.
Le sequenze ricche di intenzioni implicite e presentimenti a livello simbolico inconscio, le quali riguardano i due personaggi Ben Wade e Charlie Prince, si trovano agli inizi del film, subito dopo la presentazione della famiglia di Dan Evans di cui è già stato trattato più sopra.
Wade viene presentato in primis non come bandito, ma come artista dotato di capacità e sensibilità estetica – disegna ovunque senta la necessità di esprimere liberamente la verità dei suoi mondi interiori. Ben Wade appare dunque in un primo piano, mentre tiene la testa abbassata, così che sia ed è ben visibile la fascia alla base della corona prima della tesa del cappello, diverso da quello degli altri banditi, più originale e ben tenuto – non è un classico Stetson per intenderci –, con un tocco di raffinatezza, una fascia fittamente ed elegantemente istoriata con precisi e puliti disegni ornamentali. Anche di uno dei banditi verso la fine del film viene evidenziato per un attimo il diverso cappellaccio mal tenuto che mostra però una fascia ornata, tuttavia rozza e sbiadita, consumata, ciò che sottolinea, nel film, come non sia solo l’istoriazione ad avere un effetto estetico, ma anche e soprattutto la personalità di chi l’abbia scelta, la cura estetica che nel bandito del gruppo manca. Da non trascurare: nel retro della fascia stanno alcune ornamentazioni di colore azzurro, inquadrate in un dettaglio flash, ma di primo piano, a significare simbolicamente con la scelta del colore la qualità maschile di Ben Wade malgrado gli ornamenti. Termina l’inquadratura Ben Wade che solleva la testa e guarda in una soggettiva che porta alla successiva inquadratura relativa a un uccello su un ramo o rametto, un rapace dal petto di piume bianchissime. Nella successiva inquadratura si vede il dettaglio relativo alle mani di Wade che tengono un quaderno e finiscono di disegnare il rapace, mentre si sta avvicinando lentamente dal retro Charlie Prince pure a cavallo. Intanto l’uccello prende il volo. Dalla ulteriore soggettiva di Ben Wade si inferisce che esso si alzi sempre di più nel cielo seguito appunto dallo sguardo e volto di Wade che si indirizzano verso di lui in alto, per poi abbandonarlo come esso sia scomparso alla vista o non sia comunque più interessante per Wade. Subito dopo si ha l’inquadratura di primo piano di Charlie Prince che dopo alcuni secondi informa sorridendo Ben Wade del fatto che la diligenza trasporti denari o valori, perché ha visto o saputo che le persone di scorta hanno la Gatling – una ancora primitiva mitragliatrice dell’epoca. Wade tuttavia non gli risponde neanche, anzi appare abbastanza infastidito dalla comunicazione di Charlie Prince riguardante il prossimo assalto alla diligenza, quasi non ne volesse sapere e muove le labbra come volendo esprimere qualcosa di non piacevole al proposito. In altri termini: in questa prima sequenza di presentazione di sé e di Prince c’è già un’avvisaglia concernente l’intenzione conscia o semi inconscia o inconscia di Ben Wade di liberarsi sia di Charlie Prince che della banda. Quindi Ben Wade, lasciando Charlie Prince fermo dove stavano entrambi e, muovendosi in campo lungo in un percorso che mostra una svolta ad angolo retto, attacca dopo la svolta il disegno al tronco di un albero e prosegue il cammino. Poco dopo si muove lentamente anche Charlie Prince che si ferma in un primo piano qualche secondo a
Immagine: l'attore Ben Foster nel ruolo di Charlie Prince in: villains.fandom.com/wiki/Charlie Prince
guardare il disegno. Questo mostra l’uccello sul ramo con il petto come cancellato da un grosso segno in tutta la diagonale, segno che appare come parte più evidente di una ramificazione di cui forma il braccio maggiore di una x semi nascosta, appena accennata, tuttavia segno pure di cancellazione, una x sbilanciata verso il tracciato di cancellazione trasversale che appunto troneggia, disegno che mostra un doppio segno di cancellazione, più evidente in primo piano e più nascosto lateralmente, ma presente come testé descritto. Che il disegno si riferisca a Charlie si evince dalla successione delle immagini. Come già accennato, tale volatile è un rapace come secondo il becco tipico dei rapaci disegnato da Wade e visibile anche nell’inquadratura dell’uccello che sosta sul ramo. Quando sta arrivando Prince all’albero dove sta il disegno di Ben, il regista gli dà di nuovo un primo piano per diversi secondi mentre si ferma a guardare il disegno che, a sua insaputa, è fatto per lui: un giovane rapace – come è un predatore o predone Charlie Prince – dal petto bianco, colore dell’innocenza, ma anche segno di morte nel contesto simbolico che vede il rapace alzarsi in cielo, come lasciando la terra, la vita. È come se l’uccello, giovane rapace, nel disegno di Wade anticipasse il destino di Charlie, giovane predone la cui anima bianca – il piumaggio sta sul petto a copertura del cuore nella duplice simbologia – salirà metaforicamente nel cielo come quella di una colomba. Anima innocente e bianca in un predone altrettanto spietato come Ben Wade? Nello specifico contesto sì: Charlie Prince guarda il disegno tristemente e un po’ inquieto, ma senza mostrare di capirne i profondi significati tranne che in una intuizione inconscia che gli dà l’espressione della non letizia, è dunque in buona fede verso il suo capo, non si accorge delle sue intenzioni nei suoi confronti, come in un piano che attende di concretizzarsi. Nella scelta del rapace da disegnare esteticamente sta la premeditazione a livello simbolico come il suo privilegiato rapporto con il suo inconscio gli rende possibile, giacimento delle intenzioni non ancora consapevolmente decise. Per chiarire ancora: la premeditazione nei confronti di Charlie Prince viene per così dire manifestata nel contesto attraverso la simbologia intrinseca al disegno di Wade, attraverso un’opera d’arte, che contiene tutto il seguito dell’implicito, dei percorsi inconsci intrecciati con quelli consci. In ogni caso, a conferma della caratteristica di Ben Wade di premeditare la vendetta e la morte di singoli individui, sta tra l’altro quanto dice dopo l’assalto alla diligenza a McElroy, che Prince starebbe per uccidere dopo averlo già ferito gravemente. Dice appunto che non lo ucciderà con una semplice pallottola come preferirebbe McElroy, ma in futuro e in modo diverso, ciò che avverrà veramente. Ricapitolando in sintesi: Ben Wade ha scelto di ritrarre un rapace – come per una spinta inconscia – che sta su un ramo, la cui ramificazione, standogli davanti, lo cancella, disegno che parla con il muto linguaggio simbolico e immaginifico dei circuiti inconsci relativi alla presenza riferita alla premeditazione riguardante l’eliminazione e morte di Prince, sottolineata in aggiunta dal volo in cielo dell’uccello che Ben Wade segue con interesse. Che Wade stacchi il foglio dal quaderno in cui ha disegnato quanto lo ha attratto inconsciamente per la particolare simbologia ad esso intrinseca e lo attacchi all’albero che sta alla svolta del percorso affinché Prince lo veda – nel contesto non c’è nessun altro che possa seguire Ben –, si evince, come più sopra accennato, dalla successione delle inquadrature, molto attentamente e sapientemente curata da Mangold. Dunque l’evolversi del rapporto tra i due personaggi e di Wade con Prince e la banda stessa è già prefigurato prima di conoscere Dan e di reagire alla sua morte attuata da Prince, come nelle sequenze di presentazione dei due banditi, anche nell’ulteriore presenza della svolta ad angolo retto dopo la quale Wade attacca il disegno, appunto da una svolta prefigurata con anticipo sulla conoscenza di Evans.
Proseguendo, dopo l’assalto alla diligenza, di lì a poco Charlie Prince si impossessa, lentamente e con espressione molto seria, dell’orologio di un ucciso che giace a terra, ossia simbolicamente, in un’inquadratura significativa ad hoc, prende il tempo di un morto, tempo che si è interrotto, che è finito per sempre per il proprietario, nello speciale contesto di richiami dal profondo: un pessimo segnale di nuovo per il suo ormai vicino tempo corto o destino di morte. In altri termini: Charlie Prince prende in carico il tempo ormai terminato di un morto e lo fa suo, quasi in un presentimento inconscio del proprio breve tempo. Certo i predoni rubano qualsiasi cosa dai corpi degli uccisi, ma in questo contesto l’orologio del morto che viene raccolto, come appare, quasi misteriosamente da Charlie Prince acquisisce il significato di un ulteriore segnale della morte che si avvicina per lui. Un ulteriore segnale associabile alla sua morte, indiretto, viene dato da Prince stesso mimetizzato nell’ovvietà del contenuto di una sua affermazione. Facendo un passo indietro: dopo aver visto il disegno, Prince dice qualche parola a Wade e gli dice, sorridendo contento, che la diligenza ha la mitragliatrice, la Gatling dal nome dell’inventore, alludendo al fatto che la diligenza trasporti valori, altrimenti non avrebbe la mitragliatrice. Certo, questa è la motivazione implicita per la citazione della Gatling, ma del tutto facilmente il regista avrebbe potuto scegliere un’altra motivazione per il trasporto dei valori, ad esempio che si fosse saputo dei valori o altro di simile e non avrebbe fatto sorridere Prince compiaciuto citando la mitragliatrice, un’arma mortale cui non è facile sottrarsi e che è per i banditi un massimo rischio della vita. Invece è Prince che parla di uno strumento di morte nella speciale sequenza – non verrà ucciso durante l’assalto, ma comunque si tratta di un’associazione, indiretta e del tutto inconscia, premonitrice di morte, non di vita. In superficie Charlie sorride contento perché la mitragliatrice è segno del trasporto di valori, ma più nel profondo dell’inconscio si tratta di un intuitivo collegamento di nuovo alla propria morte che, in una nerissima ironia, si presenta camuffato sinistramente nel sorriso di Charlie Prince che pare non abbia capito l’associazione profonda. Inoltre, quando i banditi sono seduti al banco del bar di Bisbee e stanno per bere il per così dire meritato whiskey, Charlie Prince brinda ai quattro compagni morti durante l’assalto, un brindisi più che mai sinistro, e al boss che ha dovuto rinunciare con grande dispiacere, detto con ironia da Prince, anche a Tommy Darden ucciso per aver messo, forse, in pericolo la banda con la sua leggerezza – le regole della banda prevedevano che chi mettesse in pericolo la squadra anche solo per un errore, venisse ucciso dal capo. Tutti gli altri banditi verranno uccisi dal boss alla fine, senza che, all’apparenza, vi siano intenzioni pregresse ad hoc, ma agisca solo la vendetta di Wade per la morte di Dan che scarica su tutti, ma si deve tenere presente che Wade, subito dagli inizi del film, vorrebbe o ha comunque intenzione, senz’altro inconscia o semi inconscia di liberarsi di Prince che lo opprime e della vita di bandito – abbiamo visto come proponga a Emma, la prostituta del bar di Bisbee, di vivere con lui saltando dalla finestra, ossia cambiando improvvisamente e senza riflessioni, senza indugi, l’esistenza, per iniziarne una nuova dove Ben non sia ricercato, in Messico, al di là del confine, rappresentato dal fiume, dal guado, ciò per cui la donna solo lo irride. Ciò, detto per evidenziare come l’intenzione di disfarsi di tutta la banda fosse un pensiero che già dall’inizio del film, aleggiasse nella mente conscia e inconscia di Wade. Per passare il confine dunque, il fiume, c’è il guado, come testé citato e come il cognome di Ben significa dall’antico verbo anglosassone wadan, andare, guadare, oltrepassare i confini, i limiti – concetto, questo per altro, tipico e fondamentale di tutta la cultura germanica dall’antichità, a partire dai miti che si conoscono ai giorni nostri, tema su cui non possiamo soffermarci in poche righe, né è il caso di digredire. Ben Wade impersona comunque il tipo di uomo che non si ferma mai in nessun posto e che oltrepassa i confini, i limiti concreti e metaforicamente intesi. Anche il Ben Wade di Daves – il cognome sta per la prima volta nel film di Daves, ricordiamo che in Leonard il bandito si chiama Jim Kidd – dice di non fermarsi mai in nessun posto, si chiama appunto Wade, ma in Daves appare implicitamente che non si possa fermare soprattutto essendo ricercato dagli sceriffi, vorrebbe però fermarsi dopo aver conosciuto Dan e Alice e con una donna come la moglie di Dan con cui fondare una famiglia, ossia vorrebbe smettere di dover sempre andare e andare – il Ben Wade di Daves è un bandito per così dire gentiluomo, non ha in tenzione di fare male a nessuno come dice a Butterfield che sta nella diligenza. Il significato del cognome Wade è molto rilevante in Mangold soprattutto in quanto Ben Wade vorrebbe, non riuscendoci con la donna del Bar di Bisbee, oltrepassare il guado esistenziale più importante e definitivo per lui onde diventare una persona diversa – che alla fine richiami dal treno il suo cavallo testimonia del fatto che potrebbe voler evadere da Yuma come ha già fatto altre volte e continuare quindi la sua vita di fuggitivo ricercato, senza ormai più la sua banda, ma anche voler andare in Messico, oltre il guado dunque, e lì ricominciare una nuova esistenza. Tornando al bar di Bisbee e al brindisi post assalto, alle parole di ironia di Prince per il brindisi sul fatto che il boss abbia ucciso Tommy Darden, Wade risponde con una minaccia proferita con tono adirato citando dai biblici Proverbi 13 e dice che chi vigila sulla sua lingua, conserva la sua vita, mentre chi la spalanca va in rovina. Il capo rimprovera Prince e prevede esplicitamente la sua possibile rovina perché non sa tenere la lingua a posto. Ancora aggiunge perentoriamente che Tommy era debole, stupido e che è morto, così chiarendo ciò che si realizzi per tali persone, mostrando di non avere alcuna pietà per chi parli quando non deve o sbagli o anche solo abbia un’opinione diversa dalla sua, ossia nella banda domina l’assolutismo, nessuna forma anche minima di democrazia ovviamente. Ben Wade pretende assoluta e cieca obbedienza dai suoi uomini, anche dal suo braccio destro che mostra, per quanto timidamente, di non aver approvato l’uccisione di Tommy poiché, come pare ritenere, poteva essere ucciso nella circostanza solo l’uomo dei Pinkerton che si era finto morto ingannando Tommy e poi aveva minacciato tutti con il suo revolver facendosi scudo del bandito. Ma l’anima presaga di Wade non si esaurisce ancora. Uno stesso rimprovero come quello fatto a Prince per aver parlato non convenientemente verrà fatto da Wade a McElroy quando starà per ammazzarlo, ossia gli rinfaccia di non aver saputo tacere e di averlo offeso e per questo lo scaraventa giù da una rupe dopo averlo riempito a sua volta di botte, come citato più sopra. All’interno della banda, come Mangold evidenzia, non c’è alcuna libertà di pensiero, associazione molto chiara a quei regimi dittatoriali in cui la prima cosa che si impone è proprio quella di tenere la bocca chiusa, di non parlare, meno che mai di esprimere un libero pensiero scritto e orale. Tornando a McElroy, è il caso di sottolineare l’ottima interpretazione di Russel Crowe mentre viene bastonato, in altra occasione precedente, con estrema violenza da McElroy con il calcio del fucile per avere ucciso Tucker – dal nome scelto per lui: tra l’altro, uno che esaspera, sfinisce come quando canta non simpaticamente la canzoncina che tanto dà ai nervi a Wade –, dove dimostra ancora una volta di saper interpretare qualsiasi tipo di personalità in qualsiasi contesto, ossia dimostra la sua eccellenza di interprete. Mentre McElroy bastona Wade che è a terra ammanettato e gli fa sanguinare volto, bocca, denti e interno delle guance, il bandito ridacchia sarcasticamente perché intanto ha beffato Tucker mentre non se lo aspettava credendo di averlo in pugno ormai – ammanettato e quindi ritenendolo neutralizzato – e ha beffato anche McElroy che non ha saputo prevederlo. Quando Butterfield e anche Evans fermano McElroy trascinandolo via, Wade sputa sangue più volte ributtantemente, continuando a ridere sgangheratamente: Alla fine, steso a terra sfinito, sfiatato e stonando, canta molto malamente appunto la canzoncina per la quale intanto ha ucciso Tucker e ha beffato anche McElroy che per questo e non per altro lo stava ammazzando di botte – sappiamo che non ha cuore per nessuno, neanche per Tucker. Scena dedicata specificamente come omaggio alla super bravura dell’attore Russell Crowe.
Ci soffermiamo ancora, molto brevemente, su alcuni degli ulteriori segni indicativi del destino che, all’apparenza, ciascuno, almeno dei personaggi principali, importanti, porta dentro di sé o in suoi particolari comportamenti o scelte inconsce circostanziali o anche nel nome datogli da Mangold. Vediamo appunto quanto testé annunciato.
Tucker dopo l’arresto di Ben Wade si impossessa dello speciale revolver nero del bandito mostrante nell’ornamentazione una evidente croce cristiana bianca, d’avorio. Nella presenza dell’ornamentazione cristiana dell’arma maledetta di Ben Wade viene messo in evidenza, oltre a quanto già accennato più sopra, come la stessa croce cristiana non sia esente dall’essere stata all’origine di guerre e uccisioni – valga come esempio per tutti la presenza delle Crociate nella storia dell’umanità. Il pensiero religioso subisce in Mangold un attacco per quanto lieve nella dichiarazione di Dan Evans relativa alle sue costanti preghiere a Dio per tre anni, da quanto è senza una gamba, per chiedere aiuto, preghiere le quali non sono state ascoltate e cui ha posto fine, non avendo più fiducia in esse. È qui il caso di esplicitare il significato dei nomi di Dan Evans che rientrano anch’essi in un contesto ironico relativamente al pensiero religioso. Dan è l’abbreviazione di Daniel, nome ebraico che significa dio ha giudicato, giudizio di dio all’incirca, dove l’abbreviazione Dan si riferisce al concetto di giudizio, senza la citazione della divinità che resta però sottintesa, inoltre Evans richiama un’antica elaborazione inglese di Giovanni, altro nome di origine ebraica. Giovanni significa dunque in ebraico e in Evan(s) come suo derivato dio è misericordioso o dio ha favorito e simili. È come se il personaggio portasse nel suo nome il suo destino sul piano di un’interpretazione ironica alla Candide (1759) di Voltaire (Parigi 1694-1778), secondo la quale Dio sia stato misericordioso con lui o lo abbia favorito facendolo azzoppare o lasciandolo uccidere alla fine – un cognome che può simbolicamente riferirsi ironicamente anche a tutta l’umanità condannata a morte dalla divinità per chi creda alla vicenda narrata nel libro della biblica Genesi. Tornando sull’arma maledetta: è vero che Ben Wade se ne libera individualmente consegnandola nelle mani delle Istituzioni, della Giustizia, ma si tratta della medesima arma maledetta che ha istoriata la croce cristiana, e che per essere consegnata alle Istituzioni non perde la sua maledizione – la croce resta appunto come segno invariato –, consegna che, nello scetticismo espresso nel messaggio profondo di Mangold, implicitamente allude anche alla maledizione che nulla e nessuno, nel messaggio del film, cancella o toglie alla più triste alleanza tra Croce e Istituzioni, su cui qui non abbiamo intenzione di aprire un importante capitolo che allungherebbe troppo questo studio ideato per un Quaderno di più agevole lettura. È come se il passato più oscuro non potesse fare altro che continuare ad esistere nel presente e nel futuro nel mondo, sempre tenendo conto di quanto sta nel film di Mangold coerentemente sparso in tutto il film.
Riguardo ai segni per così dire del destino cui si è accennato più sopra: il dottor Potter tiene in mano subito dopo la morte di Tucker la forchetta con cui è stato ucciso, come a prendere il testimone a rovescio per essere l’ulteriore morto collegato al pensiero vendicativo di Ben Wade. Pur essendo Potter una bravissima persona, ha tuttavia salvato la vita a McElroy, dispiacendo, implicitamente, a Wade che è implacabile nella sua vendetta o giustizia per come la intende lui. Potter è inserito anche nel film di Daves, dove però è un semi alcolizzato e comunque un beone, diversamente che in Mangold, dove è un medico e dove viene messo in risalto il suo cognome: Potter significa, nel contesto mangoldiano, vasaio e di fatto vengono inquadrati in primo piano i suoi vasi di vetro contenenti ossa e parti anatomiche umane viste in soggettiva da McElroy dopo l’estrazione del proiettile dal suo corpo, ma significa anche come verbo to potter fare piccoli lavoretti qui e là, lavoricchiare e questo è il significato che il nome del personaggio acquisisce nel contesto del film di Daves. Un dettaglio ulteriore sulla citata preminenza della vendetta su ogni altro sentimento in Ben Wade: vediamo come Dan e suo figlio William si occupino molto umanamente, pur nei limiti del possibile, di Potter non lasciandolo morire da solo a terra, unico ferito a morte, mentre tutto il gruppo oltrepassa il tunnel. Padre e figlio lo ringraziano per avere permesso la fuga con il suo intervento provvidenziale, mentre da Wade non viene nessuna parola, come se il fatto non fosse accaduto, sebbene egli stesso sia stato liberato da una brutta fine proprio grazie all’audace intervento di Potter e questa assenza di una parola di riconoscenza da parte di Ben Wade parla di per sé della personalità di Ben Wade. Un dettaglio anche importante: doc Potter è un buono, come Dan Evans, e muore come Dan Evans, come nello scetticismo di Mangold sulle vicende dell’esistenza umana. Tornando a McElroy, è il primo che si avvicina a Tucker già morto n on per evitare per evitare che Wade continui a infierire – non si occupa di Tucker in nessun modo –, ma per infierire a sua volta su Ben Wade e in ciò si presenta comunque quasi come erede più diretto della sua morte per mano del bandito, ciò che accadrà realmente. Una nota anche sul nome Byron McElroy scelto per il personaggio, che è uno dei più feroci delinquenti. Byron originariamente deriva dall’antico anglosassone stalla e McElroy significa figlio del re, indicanti situazioni in apparente contrasto, ma nel contesto del film, come critica ai titoli nobiliari circa le loro origini, viene alluso alle stalle come origine di titoli come re e figli di re e simili. Anche Prince, Principe, nel contesto mangoldiano, rientra con il suo nome anche nella critica sociale antinobiliare essendo il personaggio un bandito e non solo come già in Leonard e Daves come primo nell’amicizia con Ben Wade. Sottolineando sempre: tutto ciò secondo quanto sta nel contesto del personaggio nelle tre opere e dell’ampia critica sociale espressa nel messaggio del film di Mangold.
Come testé accennato, la vendetta di Ben Wade è un percorso importante tra le pieghe inconsce della sua personalità nel messaggio del film, così che, ad esempio, risulta vero che la sua arma sia maledetta come lo è egli stesso, sfortunato negli eventi della sua infanzia quando essi non erano ancora frutto delle sue azioni. La vendetta nella personalità di Ben Wade è la giustizia retta dai giustizieri, da coloro che sono fuori dalla legalità, ciò che è una vera maledizione soprattutto per chi la agisca in prima persona e per la società stessa. Di fatto, la strage ai danni della sua banda compiuta da Wade per vendetta alla fine della vicenda anche nell’illusoria credenza di eliminare così, facilmente, il suo passato di bandito, come avrebbe voluto già dagli inizi del film, risuona come se chi sia stato nella sua esistenza giovanile lunghi anni fuori dalla Legge, come già accennato, non possa mai più rientrarvi anche volendo, quasi per una nemesi che contempli raramente eccezioni. E certo è un po’ difficile ritenere che le uccisioni di Wade di tutti i suoi compagni, attuate per vendetta esse stesse o per liberarsene, possano veramente introdurre una vita nuova per lui nell’onestà, si tratta comunque di compagni, anche se di sventura, che sono stati, pur feroci banditi esclusi dalla società, sempre ai suoi ordini comunque anche nella circostanza di doverlo liberare dal treno per Yuma – solo Prince è contravvenuto propriamente all’ordine di non sparare per motivi di cui più sopra e che sono ascrivibili, sebbene non affatto giustificabili in nessun modo, alla più cocente delusione affettiva. Vorrei soffermarmi su un dettaglio importante sul quale il regista porta l’attenzione lungo tutto il film. Si tratta, come già accennato, del revolver di Ben Wade, un’arma nera che ha una molto visibile croce cristiana, che pare di avorio, istoriata sull’impugnatura. Quando Tucker si impossessa dell’arma di Ben Wade una volta fatto prigioniero, il capo dei banditi gli dice di fare attenzione in quanto si tratta di un’arma maledetta, al che l’altro sorride con noncuranza. Nel film si vede qui e là che tale arma maledetta passa in mani di altra persona poco raccomandabile che viene uccisa da Charlie Prince, così che altri banditi la sottraggono al morto. Alla fine l’arma maledetta ritorna, passando dalle mani di alcuni banditi che se la lanciano affinché Charlie Prince la lanci a sua volta a Ben Wade, appunto nelle mani del capobanda, che la adopera per uccidere il suo braccio destro e l’intera sua banda. La maledizione sta nel comportamento del bandito che quando ne viene nuovamente in possesso, fa una strage dei suoi compagni e ammazza anche Charlie Prince, come è suo costume uccidere. E qui sta ciò su cui vorrei soffermarmi in particolare. Ben Wade consegna l'arma alle Autorità, ai rappresentanti della Giustizia, quando è salito spontaneamente, in ricordo di Dan Evans ormai morto, sul treno che lo condurrà a Yuma, dove, se non fuggirà, verrà giustiziato per i suoi tanti delitti. Consegnando l’arma maledetta, Ben Wade si libera definitivamente della maledizione ad essa intrinseca e ciò potrebbe far pensare a una sua redenzione. A parte altri dettagli da cui non risulta con chiarezza una possibile redenzione, bensì la cosa resta incerta e quasi opposta, si tratta, ricordiamolo, del fatto che la maledizione coinvolge la croce cristiana sull’impugnatura, proprio dove si afferra l’arma per sparare, uccidere -vedi più sopra il cenno alle Crociate indette in nome di Dio. Implicitamente Ben Wade potrà ancora servirsi di un'arma, magari senza l'istoriazione della croce cristiana, non comune, se non unica, senz'altro rara. Ma c’è anche un'ulteriore possibilità esegetica, meno evidente o almeno non immediatamente evidente, del tutto diversa e molto coerentemente in tema con lo scetticismo di James Mangold. Il fatto, del tipo dell’ossimorica evidenza nascosta che sfugge alla percezione cosciente, è che la maledizione intrinseca a quell’arma viene data al potere, alle Autorità, ossia non viene cancellata in nessun modo, ossia ancora: l'arma non viene buttata via, viene consegnata così com’era, nera e con la croce bianca cristiana. La Giustizia non la adopererà, diciamo la toglierà dall'uso e via dicendo con belle speranze? Non c’è nessun indizio nel film a nessun livello semantico benché minimo che possa far prevedere a ragione un tale comportamento, ci sono invece, nella totale penombra, quasi celatamente, le mani di un rappresentante del potere che la prendono in affidamento per così dire. La maledizione passa quindi al potere, una maledizione fatta di possibilità più o meno legalizzata di uccidere e ciò nell’alleanza con i rappresentanti del potere religioso, di cui la croce testimonia - sto analizzando la semantica del finale, le idee di Mangold. E certo è valida, visto il generale contesto nel film, l’associazione a quanto l’illuminista per eccellenza Voltaire aveva ritenuto, ossia che il popolo avesse diritto alla ribellione solo ed esclusivamente qualora si ripetesse l’alleanza del potere politico con la Chiesa, alleanza che l'Illuminismo aveva spazzato via con l'eliminazione del diritto divino di governare - sul colore nero dell'arma le simbologie sono per così dire autoevidenti, senza bisogno di nessun chiarimento. Un finale molto disilluso, ma queste sono comunque alcune delle idee di James Mangold relative a uno dei numerosi temi presentati nel suo complesso e interessantissimo film.
Così, con un pensiero che lascia le porte socchiuse a vari destini, termina il film di James Mangold, molto interessante e anche bellissimo come risulta dalla cura estetica di tutti i particolari della rappresentazione.
Tralasciando ulteriori dettagli e concludendo in sintesi, abbiamo messo in evidenza il particolare stile di James Mangold la cui specialità precipua consiste nell’esprimere i temi più profondi quasi offuscandoli attraverso la distanza tra le associazioni specifiche dei singoli temi così da rendere l’identificazione degli stessi, pur possibile, tuttavia meno immediata, offuscamento del profondo che va a vantaggio della comprensione di quanto emerge in superficie. In questo studio è stata data un’analisi del doppio aspetto della semantica che informa e costruisce il film di Mangold – più complesso del film di Delmer Daves, dai temi semplici e consequenziali, temi precisamente delimitati e identificabili, di sentimenti intensi e a lieto fine. Un film di James Mangold non a lieto fine dove i buoni soccombono, un film di notevole spessore e articolazione concettuale come è stato esplicitato, in cui domina l’ineluttabilità del reale, che vince su tutti i sogni di qualsiasi tipo, anche sui più onorevoli ideali di bontà e di onestà che, presentati nella loro splendida apparenza, trovano un limite insuperabile nel più profondo scetticismo di James Mangold sulla natura umana.
RITA MASCIALINO

Immagine settembre 2022: Studio Fotografico Valentina Venier | Udine Via Grazzano 38